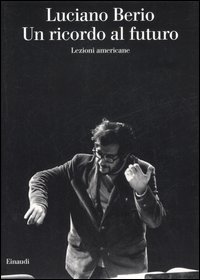25 Giugno 2009 § § permalink

Fare un film su una composizione musicale è un compito difficile e pericoloso per un regista; farlo non avendo alcuna intenzione di illustrare, ma con il coraggio di aggiungere una sceneggiatura e una drammaturgia alla musica ed eventualmente al testo cantato, è un caso più unico che raro. Lascia dunque abbastanza stupiti scoprire la bellezza di un film come War Requiem di Derek Jarman, e accorgersi di quanto poco sia stata considerata questa pellicola fuori dalla Gran Bretagna, da parte sia degli appassionati di cinema sia da quelli di musica. Eppure non si tratta di un’opera minore; anzi, qualcuno sostiene che si tratti del suo massimo capolavoro.

Girato da Jarman e prodotto da Don Boyd nel 1989, War Requiem è una grandiosa lettura visuale e drammatica della composizione che Benjamin Britten scrisse nel 1961–62 per l’inaugurazione della cattedrale di Coventry restaurata dopo le bombe incendiarie sganciate dalla Luftwaffe nel 1940. Fatta eccezione per un lungo piano sequenza iniziale, la sua storia si dispiega sulla incomparabile incisione che Britten stesso ne fece, con l’amato Peter Pears, Dietrich Fisher-Dieskau e Galina Vishnevskaya nel 1963 (l’orchestra era la London Symphony); un tenore inglese, un baritono tedesco e una soprano russa, a rappresentare le tre grandi nazioni in guerra (anche se alla prima esecuzione, quella avvenuta nella nuova cattedrale di Coventry il 30 maggio del 1962, alla Vishnevskaya era stato impedito di partecipare dal ministro della cultura sovietico). Britten non era certo la persona più adatta né alle solenni celebrazioni di marca guerriera, né alle grandi architetture religiose, e come si sa ne ricavò una delle opere di più profonda e radicale denuncia nei confronti dell’assurdità e crudeltà della guerra che mai sia stata fatta attraverso la musica; una straordinaria riflessione sulla violenza, la morte, l’amore e la poesia che mi sembra non avere paragoni nell’intera storia della musica.

Al testo latino della messa di Requiem, con il quale da ateo non si sentiva presumibilmente a proprio agio, Britten scelse di inframmezzare alcune poesie del più straziante e lirico dei poeti-soldati della prima guerra mondiale, Wilfred Owen, morto al fronte in circostanze tragiche una settimana prima della firma dell’armistizio. Si tratta di poesie che appartengono al cuore della letteratura inglese sulla Grande Guerra, intrise di un senso della pietà e di non pacificato dolore che rappresentarono il più violento urlo contro l’assurdità bellica che la letteratura dell’epoca abbia creato: il famoso Anthem for Doomed Youth (Inno per la gioventù condannata), o The Parable of the Old Man and the Young (La parabola del vecchio e il giovane), aspro sovvertimento del sacrificio di Isacco, o ancora la straordinaria, incompleta Strange Meeting (Strano incontro), in cui è descritto un allucinato e commovente incontro con un soldato nemico, sono liriche che racchiudono il pensiero di Britten sulla guerra più di qualsiasi dichiarazione genericamente pacifista. » Read the rest of this entry «
21 Maggio 2009 § § permalink

Il rapporto tra autore e libro talvolta ricorda quello fra cane e padrone. Li vedi insieme e ti sembra che l’animale rassomigli all’uomo, ne abbia assunto i tratti somatici e gli atteggiamenti; non saprai mai se è una tua fissazione – perché hai in testa quell’aspetto un po’ dinoccolato del padrone, magari, e lo stai iniquamente proiettando sul cane. Dinoccolato è il padrone, dinoccolato ti sembra anche il cane.
Io non ho conosciuto Luciano Berio, e non potrei dire se fosse dinoccolato (ma non mi pare proprio per niente). Però ho cercato più volte di conoscere la sua opera, e posso dire che Un ricordo al futuro, il libro che raccoglie le trascrizioni delle sue “lezioni americane” (Einaudi 2006, a cura di Talia Pecker Berio) le rassomigli molto. Berio ha dottissimi esegeti e allievi micidiali capaci di scagliare spaventosi anatemi, e allora metto in fila qualche caratteristica del libro, faccio finta di attribuirla solo al libro e poi passo velocemente oltre, perché non è di tutto il libro che vorrei parlare, ma di un preciso capitolo (di una precisa conferenza).
Dunque: il libro è scritto con una stranissima alternanza di zone decisamente criptiche e passaggi di canto spianato. Il libro ha delle intuizioni che ti fanno chiudere gli occhi e vedere quello che non avevi mai visto, e dei momenti che ti ricordano i pantaloni a zampa d’elefante del babbo. Il libro ha dei passaggi, a volte pagine intere, che le rileggi una, poi due, poi tre volte per capire di cosa sta parlando, e poi vai avanti facendo finta di capire, perché non ha voglia di commiserarti a ogni pagina. Il libro manifesta un amore sconfinato per l’intelligenza; un amore che a volte fa quasi paura, perché non sempre il fuoco dell’intelligenza basta a scaldarti dalla testa ai piedi; e perché magari ti è capitato di leggere autori che erano meno innamorati dell’intelligenza, ma in questo ti sembravano perfino più intelligenti; ma in ogni caso ti fa venir voglia di essere più intelligente (che è come cercare di diventare più alti). Il libro, in ogni singola conferenza, mostra uno strano equilibrio fra trattazione puntuale e divagazione improvvisa. Il libro infine sembrerebbe un sistematico panorama, ma ti rimane in testa soprattutto per molti brevi passaggi in cui ti soffia nell’orecchio intuizioni e idee molto brillanti.
Dimenticare la musica
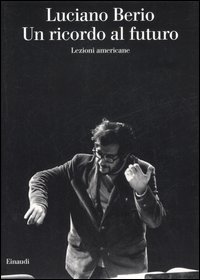 Sei bellissime conferenze tenute nel 1993–94 come titolare della cattedra di poetica Charles Eliot Norton alla Harvard University. Quella stessa cattedra che pochi anni prima aveva ispirato le Lezioni americane di Calvino, e qualche anno prima ancora The Unanswered Question di Bernstein, e prima ancora Musica e immaginazione di Copland, e prima ancora La poetica della musica di Stravinsky. E tanti, tanti altri, fra cui il recentissimo La musica sveglia il tempo di Daniel Barenboim. Sei diversi temi, tutti molto cari alla poetica di Berio. Ma fra tutte, la lezione che mi è sembrata più interessante, per quanto breve e per certi versi imperfetta, è la terza, dedicata alla memoria nella musica e al rapporto con il passato. Il titolo, bellissimo, è “Dimenticare la musica”.
Sei bellissime conferenze tenute nel 1993–94 come titolare della cattedra di poetica Charles Eliot Norton alla Harvard University. Quella stessa cattedra che pochi anni prima aveva ispirato le Lezioni americane di Calvino, e qualche anno prima ancora The Unanswered Question di Bernstein, e prima ancora Musica e immaginazione di Copland, e prima ancora La poetica della musica di Stravinsky. E tanti, tanti altri, fra cui il recentissimo La musica sveglia il tempo di Daniel Barenboim. Sei diversi temi, tutti molto cari alla poetica di Berio. Ma fra tutte, la lezione che mi è sembrata più interessante, per quanto breve e per certi versi imperfetta, è la terza, dedicata alla memoria nella musica e al rapporto con il passato. Il titolo, bellissimo, è “Dimenticare la musica”.
Sono dodici pagine, e come le altre conferenze sembrano più un invito alla riflessione che una trattazione complessiva, ma sono molto dense di stimoli per chiunque si interessi alla musica di oggi, intesa sia come interpretazione sia come composizione. Vi fanno ritorno alcuni dei temi che attraversano tutto il brevissimo libro, e che sono cari alla poetica di Berio. Vorrei per esempio citare la frase iniziale, molto bella:
Ci sono mille modi di dimenticare la musica e a me interessano i modi attivi di dimenticarla, piuttosto di quelli passivi e inconsapevoli. In altre parole, mi interessano le amnesie volontarie, anche se il desiderio e il tentativo di possedere e di ricordare tutta la storia, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, è un aspetto costitutivo del pensiero moderno; e anche se i mezzi per soddisfare questo desiderio certamente oggi non mancano.
C’è, da parte di chi ascolta, la tendenza a ricordare tutto il passato musicale come fosse un bene di consumo a lui contemporaneo. Tale tendenza ha un suo senso, perché il passato, per l’ascoltatore, è la risorsa più disponibile del sapere musicale; ma essa assume talvolta i caratteri di una inconsapevole frustrazione ideologica, avendo alle sue radici non tanto un plausibile codice di valori musicali quanto condizionamenti di mercato.
L’idea del passato musicale non come una grande biblioteca della salvezza umana (non saprei altrimenti come definirla), ma come un supermercato della confezione musicale ricorre più volte, con molteplici risonanze in questo libro. Ma poco oltre, dopo avere pagato il giusto debito estetico a Adorno, c’è una frase che mi ha colpito per come sistema le numerose e diffuse tentazioni di estenuazione del testo basate sulle microvariazioni interpretative, e il loro rapporto con il mondo del consumo:
Ma la conservazione del passato ha un senso anche negativamente, quando diventa un modo per dimenticare la musica. L’ascoltatore ne ricava un’illusione di continuità che gli permette di selezionare quanto pare confermare quella stessa continuità e di censurare tutto quanto pare disturbarla. Questa è la ragione per cui spesso l’esecuzione musicale sembra avere una vita autonoma: diventa una specie di mercanzia indifferente alla musica che dovrebbe servire. Per quanto diversificate possano sembrare le varie maniere di esecuzione, sono tutte profondamente radicate, insisto, nella società di consumo piuttosto che nel mondo delle idee.
Il virtuosismo dell’intelligenza
Quello della memoria e del rapporto con il passato è uno di temi che toccano con più intensità chiunque abbia a che fare con la musica. Una volta si sarebbe specificato “con la musica classica”, ma oggi esso riguarda in maniera altrettanto profonda il jazz e il rock. Molti compositori, da Brahms a Mahler a Stravinsky (ma anche un autore straordinario e atipico come Valentin Silvestrov, su cui mi piacerebbe tornare presto) sarebbero incomprensibili senza il desiderio, anche inconscio, di riflettere su questo rapporto. Berio stesso, in questa conferenza, dedica un passaggio molto interessante a Mahler, autore che “solitario all’interno di se stesso, elabora un discorso fatto di forze in contrasto e, appunto, complementari, esibendo in uno stesso fiato, segnali melodici banali e concezioni originali istituzionalmente incompatibili fra loro, trascendendo gesti musicali privati in dimensioni spiritualmente visionarie mai udite prima”.
Molto altro ci sarebbe da dire su questo testo, e sulle brevissime e dense analisi della Sequenza III (per voce sola) di Berio o del balletto Agon di Stravinsky che contiene. Ma preferisco chiudere qui il fin troppo lungo post, con un’altro passaggio che mi è piaciuto molto, e che offro all’altrui riflessione dopo averlo io stesso rimasticato a lungo. Si parla ancora dell’interpretazione, e nella sua lapidarietà si intravedono in filigrana tante vicende della vita e della poetica di Berio:
L’unica forma di virtuosismo degna di questo nome è il virtuosismo dell’intelligenza, capace di penetrare e rendere mondi musicali diversi.
Amare il passato, conoscerlo e farlo vivere con rispetto nel presente dell’interpretazione e della riflessione, ma saperlo anche dimenticare per affrontare in una prospettiva fresca e fiduciosa il futuro. Pur nella (mia) semplificazione estrema, mi sembra che siano non solo le parti migliori dell’estetica di Berio, ma un progetto interessante per tutti. Compositori e non.
Nella foto iniziale, il cui autore non ho ancora individuato, Luciano Berio insieme a Cathy Berberian (qui per un ricordo della Berberian)
10 Maggio 2009 § § permalink

Il 24 aprile scorso sono stati pubblicati i nomi dei vincitori del Premio Abbiati; la cerimonia di consegna, come un po’ pomposamente si chiamano queste occasioni, si terrà il 29 maggio prossimo al Teatro Sociale di Bergamo. In un precedente post, in margine ad alcune osservazioni sul Pulitzer Price, avevo manifestato una certa insofferenza nei confronti dei premi musicali italiani e dei loro meccanismi di assegnazione. L’Abbiati è il più prestigioso e ambìto di questi, forse l’unico che sappia ancora dire qualcosa al mondo musicale, e quindi vale la pena di osservarlo con attenzione.
Il premio e i suoi princìpi (o prìncipi?)
Intitolato al musicologo Franco Abbiati, per quasi quarant’anni critico del “Corriere della Sera”, il “Premio della critica musicale” viene assegnato dall’Associazione Nazionale Critici Musicali fin dal 1980 (per la precisione, l’associazione è nata nel 1986 proprio intorno alle riunioni che da diversi anni si tenevano a Bergamo per l’assegnazione del premio). Per capire che cosa rappresenti nello spazio culturale italiano (e nei desideri di chi ogni anno se ne assume le fatiche), vale la pena di citare un brano tratto dal sito dell’Associazione:
Attraverso i vincitori del Premio Abbiati, l’Associazione nazionale critici musicali ha dato spazio alle realtà locali che rappresentano l’autentica ricchezza della vita musicale italiana e che non hanno la visibilità dei grandi enti pur avendone, talvolta, l’importanza culturale. Allo stesso modo l’Associazione si è impegnata a ricordare il lavoro isolato e silenzioso di personaggi non riconosciuti dal “potere” né dai mass-media (operatori artistici, didatti, editori, “maestri” di vita non solo musicale), e a segnalare il rilievo intellettuale di fatti o manifestazioni che hanno indirizzato la vita musicale del nostro paese. Eloquente annuario più che pagella l’albo d’oro del Premio Abbiati è una sorta di promemoria artistico di oltre un quarto di secolo di musica in Italia, ma è stato anche un trampolino di lancio per giovani artisti e una dichiarazione di fiducia nei confronti di realtà poco considerate. Oltre a essere lo strumento privilegiato dell’Associazione per prese di posizione ‘politiche’, talvolta fortemente critiche, nei confronti di cruciali questioni istituzionali e legislative.
La frase sull’albo d’oro riflette l’antico ossimoro dei premi: un premio dovrebbe fare onore a qualcuno, ma onorando chi è davvero meritevole, in fondo onora soprattutto se stesso e chi lo conferisce. In questo senso, ogni premio è uno scambio: l’autorevolezza dell’artista premiato riconosce e manifesta l’autorevolezza dei premianti. Lo sapeva molto bene l’amato Thomas Bernhard, che con i premi intrattenne sempre un rapporto di amore-odio – con netta prevalenza dell’odio – e che in più di un caso si scagliò con terrificante violenza contro questo meccanismo infernale. Nel caso di un premio conferito da un’associazione di critici musicali, poi, la faccenda si fa ancora più complicata; certo, sempre meno complicata di quando sono gli organizzatori musicali a premiare i critici (vedi per esempio il Premio D’Arcangelo, che per fortuna consiste in 50 bottiglie di vino). Discorso ancora a parte, i premi per la critica musicale, in cui i critici stessi se la cantano e se la suonano da soli. L’apoteosi dell’autoreferenzialità, insomma.
Un luccicante “albo d’oro”
Ma tornando all’Abbiati, il cosiddetto albo d’oro è effettivamente un ritratto molto vivace della vita musicale italiana, con una netta prevalenza dei valori spettacolari (come in fondo è prevedibile data la composizione della giuria). Vediamo un po’, per esempio, i direttori d’orchestra. Si parte con un buffo ex-aequo Abbado-Muti (una specie di Camp David?) nella prima edizione 1980–81 – negli anni i premianti ripareranno: Muti viene ripremiato nell’88–89, Abbado nel 2000-01. In ogni caso il quadro rispecchia correttamente il meglio della vita musicale italiana (e naturalmente non solo): si comincia con i giganti storici (Bernstein, Kleiber, Celibidache, Gavazzeni, Sawallish ecc.), poi piano piano la rosa si apre e con andate e ritorni (Temirkanov vince due volte) si vede scorrere tutto il meglio che il setaccio italiano ha trattenuto dalla scena mondiale. Quest’anno il vincitore è Roberto Abbado: molto meritato e puntuale, si potrebbe dire, dati i begli spettacoli che ha inanellato nel 2008, in Italia e all’estero.
Ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto per quasi tutte le altre categorie. I registi, per esempio. Si parte con Strehler, e poi via via, compaiono gli autori, a volte accompagnati dagli scenografi, di tanti bellissimi spettacoli italiani; in più di un caso la scelta è abbastanza ardita, in altri più scontata: Ronconi-De Simone-Chéreau-Pizzi-Asari-Cobelli-Ronconi (e due)-Vick-Krämer-Ronconi/Palli (e tre)-Terleckij/Hugues-Wilson-Zeffirelli-De Ana-Vick (e due)-De Monticelli-Pountney/Bjorson-Krief-De Ana (e due)-Moschopoulos/Fotopoulos-Carsen-Martone-Medcalf-Barberio Corsetti-Michieletto. Quest’anno il premiato è Tcherniakov per il Giocatore della Scala. Anche per i cantanti, una scelta oculata che rispecchia una frequentazione continua della realtà musicale. I critici italiani girano per i teatri, ascoltano, guardano i grandi spettacoli – quelli di cui molta parte di mondo non troverà mai i biglietti – annotano, ricordano. Giudicano spesso con equilibrio, talvolta con pigrizia, ma poi premiano ciò che è importante, significativo, grande o meno grande che sia.
Quest’anno, lo spettacolo premiato (potevano esserci dubbi?) è il Fidelio di Abbado e Kraus a Reggio Emilia. Se Abbado torna all’opera, tutto il rutilante carrozzone degli amanti dello spettacolo da imperatori converge sul miracolato teatro; due recite? che importa, quanti vuoi che siano gli aventi diritto?! 2300 posti sono anche troppi. Costi? Sono coperti degli sponsor, non stiamo a ficcare troppo il naso, che poi non ci invitano più. Così è ovvio, non c’è gara. Certo, la difesa delle realtà locali che sono la ricchezza della vita musicale italiana, così com’era scritto nel fervorino dell’associazione, qui prende un significato tutto particolare; ma d’altro canto, parlare di teatro d’opera oggi richiede un “razionale e lucido pessimismo”, come dice la motivazione del premio al Fidelio. E in ogni caso si sa che le polemichette negli anni si perdono, ma l’albo d’oro rimane, lasciando al mondo un’immagine di eccellenza assoluta. E così, effettivamente, è. Ha ragione il sito, l’albo d’oro presenta un Italia dello spettacolo lirico viva e creativa. Forse con un’eccezione…
Ma siamo sicuri che la musica di oggi sia proprio questa?
Ed ecco che si ritorna a quanto si disse a proposito del Pulitzer. Certo, quel famoso (ma anche discusso, come tutto, dappertutto!) premio si limita alla creatività statunitense, e in questo senso il gioco potrebbe sembrare più semplice. Il premio Abbiati riflette invece la realtà spettacolare: cosa i critici hanno ascoltato e visto. Eppure, a un normale ascoltatore curioso della musica d’oggi che scorresse la lista dei premiati per la categoria “novità assoluta per l’Italia”, potrebbe anche prendere una stretta al cuore. Stockhausen-Donatoni-Nono-Boulez-Togni-Manzoni-Guarnieri-Kurtág-Boulez (e due)-Sciarrino-Gubaidulina-Clementi-Rihm-Berio-Holliger-Berio (e due)-Grisey-Henze-Kagel-Boulez (e tre)-Cappelli-Guarnieri (e due)-Vacchi/Carter-Romitelli-Kurtág (e due)-Lachenmann-Fedele. In 28 anni di storia musicale, l’unico americano premiato è stato Carter (però a metà con Vacchi). L’intera stagione del neoromanticismo, dei post-minimalisti dei non-avanguardisti è passata inosservata. Non un solo maverick, di qualunque colore, paese, visione o credenza (in questo senso, forse solo Gubaidulina).
Certo si potrà obiettare: il premio riguarda le prime esecuzioni assolute in Italia. Non è colpa dei critici se Andriessen o Reich o Adams (e questi non sono certo maverick) non vengono a rappresentare le loro cose per la prima volta da noi; piuttosto prendetevela con gli organizzatori musicali. Va bene. Certo che però quel Boulez premiato tre volte come compositore per Repons (1983−84), Le Visage nuptial (1988−89) e Sur incises (1999−2000), poi, naturalmente, una quarta come direttore (1986−87): non è che la cosa faccia proprio pensare a un grande sforzo di autonomia, vitalità culturale e curiosità intellettuale.
Quest’anno il premio è andato alla Phaedra di Henze del Maggio Musicale Fiorentino; in questo caso il premio non permette alcuna polemica, perché lo spettacolo era davvero molto bello: Henze è un maestro la cui forza emotiva e creativa sono una straordinaria benedizione per l’intero mondo dell’arte; Henze, che ha vinto tre Abbiati di cui due “speciali”, è tuttavia anche il massimo allontanamento consentito dal mainstream della musica contemporanea in Italia; in ogni caso “consentito” adesso, perché quarant’anni fa lo si copriva di fischi. Altro caso, Kurtág ha vinto due volte, se non si conta il premio al Festival Kurtág di “Milano Musica”; Kurtág prenderà quest’anno anche il Leone d’Oro alla carriera a Venezia. È un grande compositore, e queste convergenze non dovrebbero stupire.
E allora?
E allora la tristezza non viene dalle singole e isolate assegnazioni, tutte più o meno sacrosante dal punto di vista del valore assoluto (difficile avere un quadro sufficientemente completo di ogni singolo anno per potersi esprimere sul valore relativo); la tristezza viene dall’abissale distanza che divide questa ‘complessiva’ visione da parte della critica, rispetto alla realtà della vita musicale odierna. E parlo della realtà della musica che si ascolta, si esegue e si “consuma”, in Italia come nel resto del mondo. Una distanza che nessun’altra categoria premiata dai “giurati” dell’Abbiati mi pare rispecchiare. Perché?
Nella foto un istante della Phaedra di H.W. Henze rappresentata al Maggio Musicale Fiorentino.
2 Maggio 2009 § § permalink
Che dire di Abbado che, dopo avere ritualmente decantato la Cuba delle scuole e degli ospedali, a domanda risponde:
Però c’è il rovescio della medaglia, le violazioni dei diritti umani, i gulag…
«Ma dove? Quali?»
Niente, meglio non dire niente. Il cielo lo benedica e gli faccia fare tanta bella musica nei secoli dei secoli. Ma se qualcuno mi parla ancora di Abbado sensibile, Abbado impegnato, Abbado ecologista…
28 Aprile 2009 § § permalink

Che Krystian Zimerman non sia un uomo facile è cosa nota. Sulle sue idiosincrasie c’è tutta una letteratura, così come su praticamente ogni grande artista. E come sempre c’è chi dice con simpatia “è pazzo!”, e chi dice con livore “è furbo”.
Il blog Opera Chic, sempre informatissimo, segnalava ieri un articolo del Los Angeles Times sul debutto del pianista polacco alla Walt Disney Hall di Los Angeles, e dell’incidente che ha inaspettatamente creato. Dopo avere suonato normalmente per tutto il concerto (se si fa eccezione per la sostituzione di alcuni brani di Brahms con una sonata scritta nel 1953 della compositrice polacca Grazyna Bacewicz – le sostituzioni comunicate all’ultimo momento sono uno dei suoi scherzi preferiti), stava per attaccare l’ultimo brano del programma, le Variazioni su un tema popolare polacco di Karol Szymanowski, quando improvvisamente si è voltato verso il pubblico e ha cominciato una concione antiamericana, avvertendo di non volere più tornare in un paese “il cui esercito vuole conquistare il mondo”; ha poi continuato facendo riferimento a Guantanamo, e urlando persino “Giù le mani dal mio paese!”, mentre una quarantina di persone si alzavano e lasciavano la sala (“parli di esercito è c’è subito chi si mette a marciare” avrebbe detto, e bisogna dire che almeno questa è una buona battuta), e una parte del pubblico rimasto fischiava e lo invitava a riprendere il concerto. L’autore dell’articolo (il critico musicale Mark Swed) ci dice anche che la voce del pianista si sentiva molto poco in sala, e questo deve avere anche aumentato il ridicolo della scena.
Vale forse la pena di ricordare il precedente problema che Zimerman ebbe con gli Stati Uniti. Come altri grandi divi del pianoforte, Krystian gira il mondo portandosi dietro il suo strumento, costantemente controllato e amorevolmente tarato dalle sue stesse mani; a quanto si dice, Zimerman chiede persino di guidare personalmente il camion che trasporta il prezioso strumento da una sala da concerti all’altra. Poco dopo l’11 settembre 2001 il suo pianoforte fu fermato all’aeroporto JFK di New York e distrutto dai corpi di sicurezza della polizia di frontiera, apparentemente perché la colla aveva lo stesso aspetto (o lo stesso odore) di un certo tipo di esplosivo. Da allora, ci ricorda Mark Swed, Zimerman quando deve spostarsi in aereo fa viaggiare il suo pianoforte in pezzi separati, che vengono poi riassemblati sul posto.
Come si sa gli americani non amano che il loro paese venga denigrato. La misteriosa blogger di Opera Chic sembra furiosa con Zimerman, e ci va giù pesante; ci ricorda tra l’altro che è difficile sapere quale sia il suo paese, visto che Zimerman è residente in Svizzera. Altrettanto arrabbiati sembrano essere anche molti dei lettori del sito del Los Angeles Times. Altri invece plaudono e alcuni persino ringraziano (ma non sapremo mai di che paese sono). Sembra davvero che musica e politica non riescano più a camminare separati. È una tendenza da osservare con curiosità; senza dimenticare però che un grande artista rimane tale, e va amato anche quando ci spiazza o stupisce con la sua diversità.
Foto: © Kasskara / Deutsche Grammophon
2 Febbraio 2009 § § permalink

La vitalità di una forma artistica può essere giudicata anche attraverso la capacità di comunicare che i suoi codici simbolici conservano nel tempo. Curiosamente l’opera lirica, mille volte data per defunta e considerata alla stregua di una forma di assistenzialismo artistico persino da qualche ministro della cultura, continua a rivelarsi capace di comunicare concetti ed emozioni in una tale molteplicità di contesti da stupire anche il più appassionato dei suoi spettatori-ascoltatori.
In questi giorni è nei cinema italiani un bellissimo film del regista inglese Danny Boyle: The Millionaire (Slumdog Millionaire nella versione originale). È la storia di Jamal Malik, un ragazzo degli slum di Mumbai, e della sua lotta per sottrarsi al destino di miseria al quale sembra condannato per nascita e condizione; una lotta che è scandita dai tempi di due vicende parallele e intrecciate: la ricerca del riscatto economico attraverso la partecipazione al quiz televisivo Chi vuol esser milionario, e la disperata lotta per riavere Malika, la donna che ama fin da bambino, fin dal giorno in cui ha perso la madre, uccisa dal fanatismo religioso. Gli sta a fianco, alternativamente come spalla e antagonista, il fratello maggiore Salim, un ragazzo più violento e determinato, corresponsabile al tempo stesso del dolore e del successo di Jamal.

È un film molto ben costruito, che gioca con diversi codici simbolici e diversi ritmi: il mondo della televisione con i suoi format universali e il suo pathos, il cinema commerciale indiano con le sue convenzioni, i suoi miti e i suoi ritmi, in una girandola di fili narrativi intrecciati e salti temporali, di rimandi e allusioni che lo rende a volte persino eccessivamente “ripieno”. Ma c’è una scena che colpisce la retina e rimane misteriosamente registrata nella memoria, con tutti i significati e i simboli che porta con sé.
Jamal, Salim e Malika, i due moschettieri più uno (come si definiscono per gioco), si trovano a un certo punto del film a dover scappare da una banda di criminali che sfruttano i bambini degli slum costringendoli a chiedere l’elemosina per le strade di Mumbai; i due fratelli riescono a salire su un treno in corsa, ma Malika viene catturata. Scesi avventurosamente dal treno in quella che si scoprirà essere la città di Agra, davanti agli occhi di Jamal e Selim si dispiega improvvisamente la visione del Taj Mahal; una bellezza assurda, si potrebbe dire “fuori scala”, vista la durezza delle scene precedenti. I due bambini cominciano a vivere di espedienti attorno alle attrazioni del luogo, derubando i turisti o rivendendo le scarpe lasciate dai visitatori all’ingresso del palazzo. In seguito a uno di questi furti, Jamal viene duramente picchiato, e mentre si sta lavando le ferite nell’acqua di un fiume, sente una musica strana venire dai giardini del palazzo: noi lo sappiamo, è il suono di un oboe accompagnato dagli archi; lui comincia comincia a seguirlo, e arriva in un luogo che dato il contesto sembra quasi surreale: nei giardini si sta rappresentando uno spettacolo d’opera all’aperto, fra le luci dei riflettori e le scenografie. Mentre i suoi amici si arrampicano sui tralicci delle gradinate per rubare le borse degli spettatori, lui si sofferma a guardare.

Quella che si vede è una grande scena infernale, coperta di fuoco e solcata da rivoli incandescenti, con due persone al centro, un uomo e una donna: lei sembra morta, lui la abbraccia. Ma ciò che colpisce è quello che si sente: terminato il passaggio dell’oboe, l’uomo comincia a cantare, e le parole che intona sono di quelle che chi ama l’opera conosce molto bene: “Eurydice, Eurydice! Mortel silence! Vaine espérance! Quelle souffrance!”. È l’aria di Orfeo dal II atto dell’Orphée et Eurydice di Gluck, la famosa “J’ai perdu mon Eurydice”; l’oboe, anche se i titoli di coda non lo indicano, proviene da un’altra pagina meravigliosa, l’arioso “Quel nouveau ciel”.
Ecco la melodia dell’oboe:
arioso_gluck
ed ecco l’aria; la parte che si sente nel film è da 2:16
jai-perdu-mon-eurydice
Due tra i passaggi più patetici e profondi dell’opera, incollati con molta astuzia. L’inquadratura passa dal primo piano del viso pesto e incantato di Jamal a un flashback sul momento della separazione da Malika, il treno che corre, lei immobile che si fa sempre più lontana, e poi ancora lei, più grande, molto tempo dopo, che sorride alla stazione, in quel gioco di rimandi temporali incrociati che è una delle cose più belle di questo film.

Ecco che attraverso pochi secondi di musica, Boyle fornisce una chiave interpretativa molto forte, e lo fa utilizzando il codice simbolico del melodramma. Il desiderio, il dolore e l’ostinazione di Orfeo, che per riavere Euridice attraversa la palude infernale, sono quelli di Jamal; il suo canto, la sua prova di bravura, il gesto con cui commuove il mondo è la partecipazione a un quiz televisivo. Ma l’aria di Orfeo non è solo di dolore: contiene il senso di colpa. Orfeo piange perché la sua curiosità gli ha fatto perdere di nuovo Euridice; doveva tenere gli occhi chiusi, non doveva guardare, doveva fidarsi. Jamal è fuggito dai criminali che lo stavano per accecare; ha voluto sottrarsi a un destino segnato per sempre, ha voluto conoscere la vita, passare attraverso l’inferno del mondo per riconquistare davvero la libertà di Malika e la propria. Il significato che poche note musicali sanno portare è centrale per la comprensione del film, e curiosamente viene utilizzata un’opera del diciottesimo secolo; qualcosa di apparentemente lontanissimo dall’ambientazione della vicenda. Ma volendo guardare, c’è anche di più.
Che il codice dell’opera barocca non sia in realtà poi così lontano da quello del cinema di Bollywood, è cosa che più di un regista ci ha fatto scoprire da tempo (vedi per esempio il famoso Giulio Cesare di David McVicar). Ma anche senza abbandonarsi all’accanimento interpretativo, c’è un altro filo, chissà se del tutto casuale, che la presenza dell’aria di Gluck in quella scena porta con sé. Jamal fugge per evitare una mutilazione dettata da esigenze estetiche, pur se criminali: il canto di un bambino cieco attira dieci volte di più elemosine, dice uno dei personaggi. Gluck ha scritto quella melodia per Gaetano Guadagni, un castrato; la versione del film, tuttavia, è quella parigina per tenore… Chissà se Boyle ci ha pensato. La distanza tra le cose spesso è una questione di punti di vista; a volte sembra incredibile, ma l’opera sa ancora offrirne uno centrale e privilegiato rispetto a buona parte del nostro immaginario.
Le immagini sono tutte fotogrammi del film. I due brani musicali sono tratti dall’edizione dell’Orphée et Eurydice di C.W. Gluck utilizzata anche da Boyle per la colonna sonora. Si tratta dell’esecuzione diretta da Hans Rosbaud, con Leopold Simoneau, Suzanne Danco e l’Orchestre des Concerts Lamoureux (Philips 1956). La versione dell’opera è quella di Parigi del 1774, con Orfeo interpretato da un tenore (e Simoneau nella parte è una vera lezione di stile e fraseggio, anche se lontana anni luce dalle versioni filologiche di oggi).
20 Gennaio 2009 § § permalink

“1600 Pennsylvania Avenue” non è solo l’indirizzo della casa che da oggi avrà come nuovi inquilini Barak Obama e famiglia: è anche il titolo della meno conosciuta e rappresentata fra le opere di Leonard Bernstein. Non viene rappresentata perché non si può: la Bernstein Foundation, che raccoglie l’eredità del grande Lenny, lo proibisce; e lo proibisce perché così volle Leonard, quando lo spettacolo, un musical, l’8 maggio del 1976 chiuse i battenti dopo soltanto 7 recite, massacrato dalla critica e deriso dal pubblico. Durante le 13 “anteprime”, conscio del fatto che la debolezza fosse da addebitarsi soprattutto al libretto di Alan Jay Lerner, Bernstein chiamò al capezzale del suo spettacolo tutti i migliori amici, Jerome Robbins compreso, che furono concordi nel considerarlo irrecuperabile. Si potrebbe dire che 1600 Pennsylvania Avenue sia stata la più grande delusione della carriera di Bernstein; eppure fu anche l’opera per la quale, in assoluto, scrisse più musica: più di Candide, più di A Quiet Place. Se si vuole conoscere la storia di questo sfortunato musical, si può leggere il succinto ma preciso articolo di wikipedia.
Il libretto è un intrico di plot e subplot, il cui filo principale era definito dal curioso sottotitolo: “A musical about the problems of housekeeping”, dove la “cura della casa” (housekeeping), visto di quale casa si tratta, assume tutta una serie di significati politici e satirici. In questo filo narrativo principale sono rappresentati 12 presidenti degli Stati Uniti, da George Washington a Theodor Roosevelt (dunque dalla fine del Settecento ai primi del Novecento), ognuno con una propria particolare scena. C’è dunque il bozzetto parlamentare, con Washington e i delegati del Congresso che discutono su quale dovesse essere la capitale degli Stati Uniti, poi John Adams e consorte, quindi Jefferson che organizza un luculliano pranzo ufficiale, Madison che fugge e gli inglesi che tentano di dare fuoco alla Casa Bianca (1812), James Monroe e la moglie che non riescono a prendere sonno e discutono di schiavitù, e così via, fino all’augurio che Roosevelt porge al nuovo secolo. Dal punto di vista musicale, ogni situazione è un diverso pezzo di bravura: arie liriche, duetti, terzetti, concertati, cori, pezzi da ballo con finta musica ottocentesca, una Minstrel parade jazzistica, blues e via dicendo; si prenda per esempio lo strepitoso tour de force di un duetto per il soprano solo che si svolge durante il giuramento di Rutherford Hayes (1877), dove la stessa cantante alterna velocemente le emozioni della moglie del presidente uscente Grant e di quella dell’eletto Hayes, la prima che impazzisce di rabbia per il potere perduto e di invidia per la seconda, che invece conta i secondi che la separano dal diventare finalmente First Lady. Nonostante il fiasco, si tratta di un Berstein in gran forma.

Accanto a questo primo filo narrativo, soprattutto nella prima parte, se ne intreccia un secondo che ritrae la vita dei due domestici neri della Casa Bianca, Lud e Seena, dalla gioventù alla vecchiaia, e attraverso la loro storia (i due si innamorano, si sposano, si confrontano con i diversi presidenti) il problema della schiavitù e poi dei diritti dei neri. A tutto questo si aggiunge un terzo filo narrativo, molto di moda all’epoca e oggi piuttosto demodè: le discussioni della compagnia di attori e cantanti che sta provando l’opera, e che ogni tanto si ferma per analizzare le questioni politiche e sociali collegate. Insomma, una trama forse inutilmente intricata per un totale di più di quattro ore di spettacolo. Troppo sia per il pubblico sia per la critica.
Dopo la morte di Bernstein, pur rimanendo il veto alla rappresentazione (credo che un solo allestimento, nel 1992, superò questa censura), dallo spettacolo fu ricavata una Cantata di 80 minuti circa, che cuciva insieme i numeri musicali più belli, eliminando totalmente il subplot di “teatro nel teatro”: A White House Cantata. Nel 1998 Kent Nagano la incise per la Deutsche Grammophon, con una compagnia di canto (Thomas Hampson, June Anderson, Barbara Hendricks ecc.) che spostava decisamente in ambito lirico il sound e l’impostazione generale dell’opera, mantenendo tuttavia l’orchestrazione originale del musical. È solo da quell’incisione che oggi ci si può fare un’idea di quali perle contenesse 1600 Pennsylvania Avenue, e di quanto varrebbe la pena di riscoprirla. Alcuni numeri della partitura originale furono trapiantati da Bernstein in altri lavori, altri riuscirono a sopravvivere nonostante il veto.
Fra questi ultimi, la bellissima aria di Abigail Adams, la moglie del secondo presidente, che rivolgendosi al domestico ancora bambino gli raccomanda di prendersi cura della Casa anche quando loro non ci saranno più: “Care for this house | It’s the hope of us all”. Un song sofisticato, pieno di quel senso di felicità e facilità inventiva che è la grandezza di Bernstein, ma che lo condannerà per sempre agli occhi della critica più bacchettona.
Melodia, armonia, ritmo e retorica: difficile pensare a qualcosa di più americano di “Take Care of This House”: Frederica Von Stade, sotto la direzione di Bernstein, la cantò nel concerto dell’“Inauguration Day” di Jimmy Carter, 32 anni fa esatti esatti. Oggi il marketing del sogno di Obama ha richiesto ben altro concerto, ma per il grande amore che tutti (spero) portiamo al grande Lenny, può essere di ottimo auspicio rinnovare oggi l’invito di Abigail, con tutto il cuore: take care of this house, Barak. Dato l’inquilino precedente, ne ha molto bisogno.
take-care-of-this-house
“Take Care of This House”, June Anderson (sop.), Victor Acquah (v. bianca), da L. Bernstein, A White House Cantata, London Symphony Orchestra, London Voices, dir. Kent Nagano. Deutsche Grammophon 463 448–2.
Foto in alto: Bernstein a metà degli anni ’70, © Bernice Perry.
10 Gennaio 2009 § § permalink

Per un musicista (e più in particolare per un pianista) è un vantaggio essere mancini? Si tratta di un tema vecchissimo, sul quale ogni insegnante ha la propria teoria. Il mancino, come ogni portatore di una qualche diversità dalla maggioranza, ha sempre destato sospetti: in tutte le lingue che io conosca esistono vocaboli che mettono in relazione ciò che è “sinistro” con l’infido, il maligno (che non a caso zoppica, e naturalmente dal piede sinistro). Ci sono insegnanti che con incredibile perseveranza e crudeltà hanno costretto gli allievi mancini a scrivere con la destra; in campo musicale, esistono strumenti a corda per mancini (con le corde, e dunque le relative strutture di sostegno, invertite), e ultimamente c’è anche chi costruisce pianoforti per mancini, anche se la cosa può sembrare totalmente folle.
Ma naturalmente c’è anche l’altra versione. E meno male. Il mancino è portatore di una diversità che, come ogni diversità, può costituire uno straordinario vantaggio non solo per lui, ma per la società intera. D’altro canto non si tratta certamente di una caratteristica rara: si stima che il dieci per cento della popolazione mondiale sia mancino. Ma tornando all’interrogativo iniziale, per un pianista è un vantaggio oppure no? Un piccolo aiuto può venirci da un curioso articolo di Pierre Ruhe pubblicato dall’«Atlanta Journal-Constitution», il principale quotidiano di Atlanta (ringrazio Bart Collins per la segnalazione). Curioso perché non sembra essere stato suscitato dalla comparsa di un nuovo studio o da una dichiarazione di qualche scienziato, ma probabilmente solo dal desiderio di presentare il direttore principale ospite della Atlanta Symphony Orchestra, Donald Runnicles, da un diverso punto di vista; ciò nonostante l’articolo contiene molte informazioni interessanti.
Come molti destri, la mia personale opinione, per esempio, si basava sul luogo comune che essendo la mano destra, tradizionalmente, quella dell’agilità, lo studio del pianoforte potesse rivelarsi particolarmente impegnativo per un mancino; è probabile che l’argomento comporti (inconsciamente) un testo sottotraccia: la mano destra è quella dell’agilità perché la musica è stata composta da musicisti destri per interpreti destri. La sorpresa sta invece nello scoprire che non solo molti grandissimi pianisti erano o sono mancini (Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein, Glenn Gould, Daniel Barenboim, Radu Lupu, Leif Ove Andsnes), ma anche moltissimi grandi compositori; la lista comprende C.P.E. Bach, Beethoven, Schumann, Brahms, Rachmaninoff e Scriabin. E allora, come la mettiamo?
Ma l’articolo si spinge oltre, e afferma che l’essere mancino per un pianista è un vantaggio, come spiega Russel Young, direttore del dipartimento di opera e teatro musicale della Kennesaw State University:
[Se sei mancino] leggi la musica stampata sulla pagina dal basso verso l’alto. Una volta che hai compreso la linea di basso, ne ricavi un’idea più solida della struttura armonica, dato che la mano destra il più delle volte è occupata dal libero andamento melodico.
Non poteva mancare l’opinione dello scienziato. Samuel Wang, docente di Neuroscienze a Princeton, e coautore di Il tuo cervello. Istruzioni per l’uso e la manutenzione (Mondadori 2008) – il pazzo titolo dell’edizione americana era Welcome to Your Brain: Why You Lose Your Car Keys But Never Forget How to Drive and Other Puzzles of Everyday Life – ci spiega che la prevalenza (addirittura!) dei mancini tra i pianisti di massimo livello è un fatto scientificamente prevedibile, poiché suonare a quel livello “è estremamente impegnativo, e qualsiasi vantaggio, per quanto piccolo, si mette subito in forte evidenza”; e prosegue:
I pianisti devono coordinare l’attività di entrambi gli emisferi del cervello, dal momento che ciascuno di essi è responsabile per il movimento di una separata mano. [Nel campo del linguaggio] un mancino su sette coordina il linguaggio attraverso entrambi gli emisferi, mentre tra i destri il rapporto è di uno a venti. Questo comporta il vantaggio di avere il doppio di “spazio disponibile” cerebrale per governare il linguaggio, e può spiegare la quantità di mancini verbalmente dotati – vengono in mente Clinton e Obama.
Lasciando da parte quest’ultima considerazione (poco prima ci era stato spiegato con fierezza che sei degli ultimi dodici presidenti degli Stati Uniti erano mancini), a seguire quest’articolo sembrerebbe dunque che la risposta alla domanda di partenza sia affermativa. Certo, mi piacerebbe sentire quanti maestri di pianoforte sono d’accordo, però l’argomento è interessante, perché al di là del vantaggio tecnico, si allude a una diversa “sensibilità” nei confronti del suono e della struttura della musica, cosa che si riflette nella scrittura e nell’interpretazione.
In ogni caso, l’articolo ci avverte che Runnicles, quando dirige la Atlanta Symphony, rovescia specularmente la disposizione dell’orchestra: “per sentire i bassi nella mia mano dominante, in analogia con quanto avviene al pianoforte”.
Foto in alto: Beach Hand, © di Wzrdry
5 Gennaio 2009 § § permalink

Venerdì 2 gennaio, a pagina 5 della «Repubblica» è apparso un breve articolo in cui Daniel Barenboim commenta la drammatica situazione della striscia di Gaza; non l’ho trovato sul sito del giornale, e così lo ricopio io stesso. È un intervento semplice e diretto, che affronta a viso aperto la tremenda difficoltà del conflitto (un “conflitto umano” lo chiama, con quella che mi sembra una bellissima espressione), indicando senza abbandonarsi al luogo comune pacifista l’esigenza inevitabile di una riapertura del dialogo. Barenboim è un musicista, non un politologo, ma scrive e agisce dimostrando la convinzione che nulla di ciò che accade ci possa essere estraneo, ben sapendo che la posizione privilegiata offertagli dallo straordinario livello artistico del suo lavoro può anche essere utilizzata per intervenire nelle grandi emergenze del momento. Ecco il testo:
Per il nuovo anno ho tre desideri. Il primo è che il governo israeliano si renda conto, una volta per tutte, che il conflitto in Medio Oriente non può essere risolto con mezzi militari. Il secondo, è che Hamas si renda conto che non è suo interesse servirsi della violenza e che Israele è qui per rimanere. Il terzo è che il mondo riconosca che questo è un conflitto diverso da tutti gli altri conflitti della storia. È un conflitto complesso e delicato come nessun altro; è un conflitto umano tra due popoli, entrambi profondamente convinti del loro diritto di vivere sul medesimo piccolo lembo di terra. Ecco perché né la diplomazia né l’azione militare possono risolverlo. Gli sviluppi degli ultimi giorni mi preoccupano terribilmente per molte ragioni, sia di natura politica che umana. Sebbene sia di per sé evidente che Israele ha il diritto di difendersi, l’implacabile e brutale bombardamento di Gaza da parte dell’esercito israeliano ha fatto nascere nella mia mente alcuni gravi interrogativi. Il primo è se il governo israeliano abbia il diritto di ritenere tutti i palestinesi colpevoli delle azioni di Hamas. Si può considerare l’intera popolazione di Gaza responsabile dei peccati di un’organizzazione terroristica? E poi, se l’uccisione di civili è inevitabile, qual è lo scopo di questi bombardamenti? Se l’obiettivo delle operazioni è quello di distruggere Hamas, allora la domanda più importante da porsi è se si tratta di un obiettivo raggiungibile. Se non lo è, l’intero attacco è non soltanto crudele, barbaro e riprovevole, ma anche insensato. Se invece fosse davvero possibile distruggere Hamas attraverso le operazioni militari, quale reazione Israele prevede che potrà verificarsi a Gaza una volta conseguito tale obiettivo? Un milione e mezzo di cittadini di Gaza non si inginocchieranno improvvisamente di fronte alla potenza dell’esercito israeliano. La recente storia di Israele mi porta a ritenere che se Hamas venisse distrutta, quasi certamente il suo posto verrebbe preso da un’altra organizzazione, un’organizzazione ancora più estremista, violenta e carica di odio nei confronti di Israele di quanto non sia oggi Hamas. Israele non può permettersi una sconfitta militare per paura di scomparire dalla carta geografica; tuttavia la storia ha dimostrato che tutte le vittorie militari hanno sempre lasciato Israele in una posizione politica più debole a causa dell’affiorare di nuovi gruppi estremisti. Non sottovaluto la difficoltà delle decisioni che il governo deve prendere ogni giorno, né l’importanza della sicurezza. Ciò nonostante, resto dell’idea che l’unico piano di sicurezza a lungo termine veramente attuabile sia quello di conquistare l’accettazione di tutti i nostri vicini. Mi auguro che il 2009 segni il recupero della famosa intelligenza da sempre attribuita agli ebrei. Mi auguro che coloro che detengono le chiavi del potere ritrovino la saggezza di Re Salomone e la impieghino per capire che palestinesi ed israeliani hanno gli stessi diritti umani. La violenza palestinese tormenta gli israeliani e non serve alla causa della Palestina; le ritorsioni dell’esercito israeliano sono inumane, immorali e non garantiscono la sicurezza di Israele. Come ho già detto, i destini dei due popoli sono inestricabilmente intrecciati, e li obbligano a vivere l’uno accanto all’altro. Essi devono decidere se vogliono che ciò sia una benedizione o una condanna.
Una posizione del genere, nella quale l’artista dimostra di essere umanamente radicato nella storia del presente, con competenze e convinzioni serie e fondate e il desiderio di discuterle pubblicamente, è un’eccezione. Gli artisti, anche quelli di ottimo livello intellettuale, generalmente sfuggono a qualsiasi discussione che li possa costringere a prendere una posizione, anche quando passano per “impegnati”.
Pochi giorni prima mi era capitato di leggere l’intervista di Giuseppina Manin a Claudio Abbado, pubblicata sul «Corriere della Sera» del 30 dicembre. Certo, il contesto è molto diverso; certo, il tono è volutamente più leggero; certo, si tratta di un’intervista e non di un articolo. Ma non è la prima volta che un musicista come Abbado, a cui la vita ha dato molte più possibilità di vedere, di incontrare e di conoscere che a gran parte di noi, esprime le sue opinioni sul presente con questa distanza aristocratica. Personalmente la differenza mi ha fatto una certa impressione, ma ognuno faccia le sue valutazioni. È una questione di tono, di rapporto con il mondo e con il presente storico. Una “questione umana” verrebbe da dire, parafrasando Barenboim.
28 Dicembre 2008 § § permalink
 Allevi ha risposto all’intervista in cui Ughi si diceva offeso dal concerto di Natale al Senato (vedi post del 24 dicembre). Come ha risposto? Con una Lettera Aperta. In fondo quello che riguarda lui riguarda l’Arte, e dunque due righe avvelenate nella pagina della Posta gli sarebbero sembrate da morti di fame. E cosa scrive, in questa Lettera Aperta? Fa l’Allevi. Una miscela di furberia, giovanilismo piagnone, autocommiserazione che poi diventa autoesaltazione per concludersi nell’autotrionfalismo più scatenato (spacciato per “visionarietà”).
Allevi ha risposto all’intervista in cui Ughi si diceva offeso dal concerto di Natale al Senato (vedi post del 24 dicembre). Come ha risposto? Con una Lettera Aperta. In fondo quello che riguarda lui riguarda l’Arte, e dunque due righe avvelenate nella pagina della Posta gli sarebbero sembrate da morti di fame. E cosa scrive, in questa Lettera Aperta? Fa l’Allevi. Una miscela di furberia, giovanilismo piagnone, autocommiserazione che poi diventa autoesaltazione per concludersi nell’autotrionfalismo più scatenato (spacciato per “visionarietà”).
 Dunque comincia con una favoletta, quella del giovane compositore che va a un concerto della grande star Uto Ughi e ne resta tanto colpito da andare nel suo camerino a chiedergli un autografo: è l’unico autografo che Allevi abbia mai chiesto a un artista, ed è successo 10 anni fa. Che strana idea, quella diarrivare a 28 anni senza chiedere mai un autografo a nessuno, e poi improvvisamente chiederlo a Uto Ughi. Boh. In ogni caso, ottenuto il prezioso feticcio, Allevi torna nel suo monolocale; perché ci dà la metratura di casa sua? Perché ci vuole dire che è povero, è fuori dai giochi, non conosce nessuno del mondo rutilante dello spettacolo:
Dunque comincia con una favoletta, quella del giovane compositore che va a un concerto della grande star Uto Ughi e ne resta tanto colpito da andare nel suo camerino a chiedergli un autografo: è l’unico autografo che Allevi abbia mai chiesto a un artista, ed è successo 10 anni fa. Che strana idea, quella diarrivare a 28 anni senza chiedere mai un autografo a nessuno, e poi improvvisamente chiederlo a Uto Ughi. Boh. In ogni caso, ottenuto il prezioso feticcio, Allevi torna nel suo monolocale; perché ci dà la metratura di casa sua? Perché ci vuole dire che è povero, è fuori dai giochi, non conosce nessuno del mondo rutilante dello spettacolo:
Io non avevo amicizie influenti, a stento arrivavo alla fine del mese, affrontavo grandi sacrifici per diplomarmi in Composizione e il biglietto del concerto l’avevo pagato. Ma ora avevo l’autografo di uno dei più valenti violinisti del mondo: lei, Maestro Ughi.
Ecco, praticamente la piccola fiammiferaia. Ma la fase dell’autocommiserazione dura poco. Mentre la “casta” difendeva i suoi onori e le sue ricchezze, Allevi studiava duramente, confortato dalla Fenomenologia di Hegel (!). Ed ecco che, all’improvviso arriva l’illuminazione. Allevi capisce la propria missione:
Perché costringere il pubblico del nostro tempo a rapportarsi solo a capolavori concepiti secoli fa, e perdere così l’occasione di creare una musica nuova, verace espressione dei nostri giorni, che sia una rigorosa evoluzione della tradizione classica europea? La musica cosiddetta «contemporanea», atonale e dodecafonica, in ogni caso non è più tale, perché espressione delle lacerazioni che agitavano l’Europa in tempi ormai lontani. Ecco allora il mio progetto visionario. È necessario uno sforzo creativo a monte, piuttosto che insistere solo sull’educazione musicale, gettando le basi di una nuova musica colta contemporanea, che recuperi il contatto profondo con la gente. Ho provato a farlo, con le mie partiture e i miei scritti. È stato necessario.
Il giochino è abbastanza semplice: si dice che la musica contemporanea è quella delle lacerazioni del passato, quella brutta e difficile, insomma quella derisa da Alberto Sordi nelle Vacanze intelligenti. E quindi il suo tentativo diventa quello di ricucire lo strappo, di ridare al presente una musica del presente. Ora, che il suo problema sia stato posto da gran parte dei compositori degli ultimi trent’anni (e più) lui non lo dice. Lui legge Hegel e capisce cosa deve fare; che ci sia stato un minimalismo americano, e poi un postminimalismo, che in Italia sia stata scritta della musica definita neoromantica, che mezzo mondo non navighi più nella scia di Boulez, Allevi fa finta di non saperlo, e in ogni caso non lo dice. Ed ecco che l’accusa di sfruttare l’ignoranza della gente diventa piuttosto ragionevole. Ma l’ardito innovatore si spinge più in là:
Da amante di Hegel, quindi, sapevo benissimo che l’ondata di novità avrebbe mandato in crisi il vecchio sistema e che i sacerdoti della casta, con i loro adepti, non potendo riconoscere su di me alcuna paternità, avrebbero messo in atto una criminale quanto spietata opera di «crocifissione di Allevi».
Ora, che Allevi sia stato addirittura “crocefisso” dai sacerdoti della casta è cosa alquanto difficile da sostenere: è coccolato e invitato da tutte le maggiori istituzioni musicali, è presentato a tutte le ore su tutti i canali televisivi e radiofonici come il nuovo Mozart e, con tutto il rispetto, non mi sembra che Ughi abbia la statura per impersonare il Salieri del film di Forman (e del dramma di Schaffer). Ma la sua rivoluzione parte dal basso, vuole dirci:
Non c’è alcuna macchinazione, tutto è assolutamente limpido e puro: le persone spontaneamente hanno scelto di seguirmi. Ma bisogna smettere di ritenere ignorante la gente «comune». Il pubblico cui si rivolgeva Mozart nel XVIII secolo era forse più colto del nostro?
Eppure era chiaro che nessuno si fosse mai detto offeso dal successo di Allevi. Ognuno ha il diritto di scrivere e di ascoltare quello che preferisce. Il problema nasce quando qualcuno ti dice che ciò che sta facendo è l’eccellenza di un certo ambito, ma qualsiasi considerazione stilistica, estetica e storica che abbia un minimo di costrutto indica platealmente il contrario. E qui, curiosamente, Allevi usa un argomento abbastanza inconsueto: invece di sostenere che non ha senso chiedersi se la sua musica sia “classica” o meno – si consideri che tutto nasce da un concerto al Senato spacciato per concerto classico di altissimo livello – usando la vecchia e alquanto usurata argomentazione della scomparsa delle distinzioni fra i generi musicali, dell’esigenza della contaminazione, del meticciaggio ecc., invece di fare tutto questo, lui rivendica la purezza razziale della sua musica:
È una musica colta che non può prescindere dalla partitura scritta e che rifiuta qualunque contaminazione, con le parole, con le immagini, con strumenti musicali e forme che non siano propri della tradizione classica. […] La mia è una musica classica, perché utilizza il linguaggio colto, la cui padronanza è frutto di anni di studio accademico. […] La mia non è una musica pop, perché non contempla alcun cantante, alcuna chitarra elettrica e batteria e non usa la tradizione orale, o una scrittura semplificata come mezzo di propagazione…
Insomma non è uno scherzo: Allevi vuole proprio affermare che la sua è la “musica classica” del presente e del futuro, e che l’unico motivo per cui una persona come Ughi – che con la musica contemporanea “lacerata” e dissonante ha lo stesso legame che potrebbe avere con l’heavy metal – lo rifiuta è perché Ughi è un Gran Sacerdote della casta passatista. Abbastanza incredibile.
Ma il vero capolavoro è la chiusa, dove sotto i lineamenti dell’artista del futuro si riaffacciano quelli, imbronciati, della piccola fiammiferaia: “Quel suo autografo che ho sempre conservato gelosamente, dopo tanti anni, per me ora non conta più niente”. Addio, Bruto Ughi!