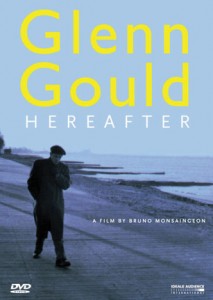30 Ottobre 2007 § § permalink
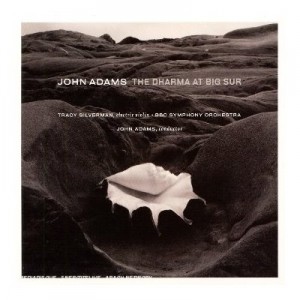 È strano come il concerto solistico, ben lungi dall’essere in qualche modo ridimensionato dalla fine di un mondo, quello del grande concertismo internazionale, continui a generare nei migliori compositori ispirazioni spesso più felici della musica per orchestra. Gli ultimi grandi divi-virtuosi si stanno spegnendo, nascono figure di volta in volta più “glamour” o più tecnicamente preparate, ma difficilmente si potrà ritrovare, almeno nel futuro prossimo, quel particolare carisma che il solista conquistava con l’appartenere a un mondo che aveva qualcosa da dire, che rappresentava qualcosa oltre a se stesso. Eppure di quel mondo si nutriva la forma stessa della musica: difficile pensare al ruolo, alla voce che il violino “porta” nel concerto di Brahms senza Joachim, o al violoncello di Sostakovic senza il rimpianto Rostropovich.
È strano come il concerto solistico, ben lungi dall’essere in qualche modo ridimensionato dalla fine di un mondo, quello del grande concertismo internazionale, continui a generare nei migliori compositori ispirazioni spesso più felici della musica per orchestra. Gli ultimi grandi divi-virtuosi si stanno spegnendo, nascono figure di volta in volta più “glamour” o più tecnicamente preparate, ma difficilmente si potrà ritrovare, almeno nel futuro prossimo, quel particolare carisma che il solista conquistava con l’appartenere a un mondo che aveva qualcosa da dire, che rappresentava qualcosa oltre a se stesso. Eppure di quel mondo si nutriva la forma stessa della musica: difficile pensare al ruolo, alla voce che il violino “porta” nel concerto di Brahms senza Joachim, o al violoncello di Sostakovic senza il rimpianto Rostropovich.
Eppure il concerto solistico continua la sua strada, con dei momenti di altissima ispirazione. The Dharma at Big Sur è uno di essi. Scritto per l’eccezionale violino elettrico a cinque corde di Tracy Silberman, dimostra quanta strada continui a fare John Adams senza lasciarsi acciuffare dall’etichettatrice della critica, cercando, sperimentando e più di una volta trovando. Due movimenti per un totale di 27 minuti circa, organico ricco, forma complessa e colma di ricercatezze, tante citazioni e omaggi ma scarsissima propensione alla parodia. Un pezzo veramente bellissimo, che non ci si stanca di riascoltare, che non rifugge il pathos ma senza neoromanticismi. In Italia lo suona (e bene, dice chi lo ha ascoltato) Francesco D’Orazio.
Ora lo si può ascoltare in un prezioso doppio cd, accostato a un’altra e diversissima composizione recente di Adams, My Father knew Charles Ives. Un pezzo più riflessivo (si tenga conto del fatto che The Dharma at Big Sur era stato scritto per l’inaugurazione della Walt Disney Hall) ma sempre caratterizzato dalla stessa controllata estroversione; una voglia di comunicare senza svendere la propria personalità creativa. Ma al tempo stesso un altissimo controllo delle dinamiche, della strumentazione, dello stile. Più ricco del precedente di omaggi alla tradizione musicale americana (a Copland più di tutti), fitto di riferimenti autobiografici e familiari, con quella tendenza all’epicizzazione del privato che solo gli americani sanno avere (è per questo che amano tanto Mahler?). Tre movimenti per 26 minuti circa di musica; misterioso il motivo della ripartizione in due cd dei contenuti (naturalmente il costo è quello di un singolo). Una delle migliori cose che abbia ascoltato di recente.
20 Ottobre 2007 § § permalink
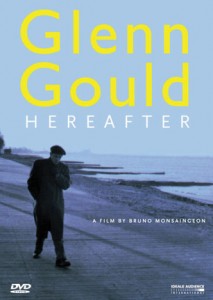 Forse qualcuno poteva pensare che Bruno Monsaingeon avesse già detto tutto su Glenn Gould, dopo quattro libri e sei o sette film. Eppure Glenn Gould Hereafter è un grande piacere per gli occhi e la mente. Qui spezzoni editi e inediti di “girato” con Gould come protagonista (ce ne sono centiaia di ore molte delle quali mai viste se non all’epoca) si alternano a episodi che riguardano la posterità di un artista così particolare. Sei personaggi, fra cui una simpatica signora bolognese, raccontano il loro rapporto con Gould, la nascita della loro passione e il peculiare modo attraverso cui si esprime. La giovane pianista che si è fatta tatuare il tema del quartetto di Gould sulla schiena, l’anziana signora russa il cui ultimo scopo di vita è “gouldianizzare” il mondo, il giovane giapponese che recapita le lettere con destinatari giapponesi che Gould ha scritto e mai spedito, e altri ancora. Poteva derivarne un atto di adorazione stucchevole, un prodotto confezionato per i tanti maniaci del pianista-mito, e invece Monsaingeon riesce a costruire un film intelligente, ricco e commovente.
Forse qualcuno poteva pensare che Bruno Monsaingeon avesse già detto tutto su Glenn Gould, dopo quattro libri e sei o sette film. Eppure Glenn Gould Hereafter è un grande piacere per gli occhi e la mente. Qui spezzoni editi e inediti di “girato” con Gould come protagonista (ce ne sono centiaia di ore molte delle quali mai viste se non all’epoca) si alternano a episodi che riguardano la posterità di un artista così particolare. Sei personaggi, fra cui una simpatica signora bolognese, raccontano il loro rapporto con Gould, la nascita della loro passione e il peculiare modo attraverso cui si esprime. La giovane pianista che si è fatta tatuare il tema del quartetto di Gould sulla schiena, l’anziana signora russa il cui ultimo scopo di vita è “gouldianizzare” il mondo, il giovane giapponese che recapita le lettere con destinatari giapponesi che Gould ha scritto e mai spedito, e altri ancora. Poteva derivarne un atto di adorazione stucchevole, un prodotto confezionato per i tanti maniaci del pianista-mito, e invece Monsaingeon riesce a costruire un film intelligente, ricco e commovente.
Il tema di fondo è quello dell’eredità, del retaggio che Gould ha lasciato alla posterità, della prodigiosa capacità epidemica che i virus di un artista di questo valore mantengono nel tempo. Dopo la visione rimangono nelle mente due considerazioni, fra le tante che il film solleva. La prima è che un artista che decide di presentare una precisa immagine di sé al mondo crea una più o meno grande barriera fatta di immagini, suoni e parole che ci danno la sensazione di conoscere, quasi di possedere interamente la sua anima. Ma guardandole molto da vicino, collazionandole con attenzione ci si accorge del trucco, del fatto che tutto è proiettato su uno schermo, e che fra questo schermo e l’artista sussiste un vuoto incolmabile. Così nasce il mistero, e così nascono le forme maniacali attraverso cui si cerca di colmarlo. Non diversamente che in amore, forse. La seconda è che effettivamente Gould ha rappresentato un tipo di artista con cui non smettiamo di dover fare i conti. Una delle scene più belle del film è uno dei famosi incontri fra Gould e Menuhin; i due artisti discutono della preminenza del concerto dal vivo o della registrazione in studio nella percezione musicale del futuro. La distanza che li divide è grande: due mondi le cui massime espressioni si sfiorano senza capirsi. Menuhin sopravviverà a Gould per quasi diciassette anni, la sua eredità artistica rimarrà per sempre altissima, tra le massime del Novecento; ma il retaggio umano, artistico e intellettuale di Gould giganteggia, superando il confine del secolo in cui è nato e disseminando il presente di quei molti dubbi e inquietudini che solo la grande arte sa (e forse deve) trasmettere.
J.S. Bach, Gavotta dalla Suite francese n. 6 (1971)
gavotte
18 Ottobre 2007 § § permalink

George Steiner ci ha abituati a una scrittura che si fa quasi venerare per il suo controllo stilistico, la sua passionalità intellettuale e lo sfoggio di una tale ricchezza di rimandi e associazioni da diventare la quintessenza stessa di ciò che normalmente definiamo “cultura”; ma ci ha anche abituati a posare i suoi libri pieni di illuminanti idee e di insistenti dubbi. I suoi fuochi d’artificio sulla responsabilità del critico in Linguaggio e silenzio, la sua visione del processo di traduzione in Dopo Babele, le intuizioni di Grammatiche della creazione arricchiscono la vita intellettuale e la sensibilità del lettore in maniera si potrebbe dire ‘irreversibile’. Ma spesso hanno un fondo di incompletezza che si riverbera nell’animo del lettore in un supplemento di discussione. È tutto straordinariamente argomentato, ma indissolubilmente legato alla personale visione e intelligenza del suo creatore.
Questo vale in misura anche maggiore per questo strano libretto. Strano in molti sensi: una trentina di pagine di Steiner, provenienti da una lezione al Nexus Institute di Amsterdam, precedute da una Introduzione di Rob Riemen, direttore dell’Istituto, e da uno scritto di Vargas Llosa che contraddice apertamente le idee di Steiner. Invitato a fornire una sua definizione di Europa, Steiner articola la sua visione su cinque ‘assiomi’, tutti fortemente letterari e culturalmente stimolanti: i suoi caffè come simbolo di una civiltà del confronto e della dialettica; un paesaggio su scala umana, sempre percorribile a piedi e, anzi, stratificatosi nei secoli proprio in base a un’idea di mobilità dei corpi e delle idee su scala antropomorfica; la presenza pervasiva della memoria e dell’autocoscienza, testimoniata dai nomi di strade, quartieri e piazze ispirati ai grandi personaggi della storia; la duplice discendenza da Atene e Gerusalemme (si tenga presente che per Steiner il cristianesimo è una ‘nota a piè di pagina’ della religione ebraica); e infine una specie di nera consapevolezza di appartenere a un ‘capitolo conclusivo’, al lungo tramonto di una civiltà. Cinque concetti che hanno definito l’Europa, ma che ne possono aal tempo stesso decretare l’impossibilità di competere con civiltà più giovani e agguerrite.
E il futuro? Per esso Steiner si limita ad alcune, semplici proposte, articolate in quella che definisce «una modalità dilettantesca e provvisoria». La forza d’Europa nascerà dal reperimento di un delicato e innovativo equilibrio tra la diversità e l’unità, tra le mille lingue (tutte portatrici di una peculiare cultura) e l’esigenza di comunicare. «Il genio dell’Europa è quello che William Blake avrebbe definito “la santità dei minimi particolari”», dice in una delle sue frasi fulminanti. Poi però il discorso si fa via via più confuso, e forse persino generico. L’Europa riuscirà a assumere di nuovo un ruolo guida nel mondo se saprà fare i conti con il proprio passato di odio e di violenze (ed ecco emergere lo quella straordinaria cupezza di fondo che colpisce i lettori più attenti di Steiner); se saprà fare i conti con l’odio razziale e religioso che l’intolleranza del cristianesimo ha sostenuto e fomentato; se saprà ristabilire la dignità e la centralità laica dell’homo sapiens, e allontanare le tentazioni del consumismo e del mercato. L’Europa dovrà saper richiamare i nostri cervelli in fuga per trasformarsi in un grande laboratorio umano e intellettuale. Ancora una volta una teoria appassionante quanto bisognosa di discussione e approfondimento.
Vargas Llosa, in quattro pagine di Intoduzione, esprime il suo totale disaccordo dalla visione cupa che Steiner manifesta sullo stato della nostra civiltà culturale, ma al tempo stesso si fa quasi beffe della strana utopia che da essa deriva: mai Mallarmé e Joyce hanno avuto tanti lettori, mai la cultura ha conosciuto una diffusione tanto trasversale e democratica quanto ai nostri giorni. Inutile illudersi, tuttavia: «quella cultura che George Steiner ama e conosce meglio di chiunque altro sarà sempre minoritaria”.
18 Ottobre 2007 § § permalink
 Non capita molto spesso di ascoltare una nuova opera con la sensazione di trovarsi di fronte a un lavoro di grande felicità espressiva e ricchezza culturale. È però il caso di Writing to Vermeer, l’opera composta da Louis Andriessen negli anni 1997–98 su commissione di De Nederlandse Opera di Amsterdam, dove ha debuttato nel 1999. La si può ora ascoltare in un doppio cd, molto ben confezionato dalla Nonesuch.
Non capita molto spesso di ascoltare una nuova opera con la sensazione di trovarsi di fronte a un lavoro di grande felicità espressiva e ricchezza culturale. È però il caso di Writing to Vermeer, l’opera composta da Louis Andriessen negli anni 1997–98 su commissione di De Nederlandse Opera di Amsterdam, dove ha debuttato nel 1999. La si può ora ascoltare in un doppio cd, molto ben confezionato dalla Nonesuch.
L’opera si compone di sei scene, nelle quali si intersecano diverse linee di articolazione drammatica, psicologica, intellettuale e musicale. La base è un affascinante libretto di Peter Greeneway, sostanzialmente privo di azione drammatica ma al tempo stesso dotato di un particolare crescendo ansiogeno, amplificato con grande sapienza drammaturgica da Andriessen. Tra il 16 e il 26 maggio 1672, tre donne scrivono sei lettere ciascuna a Johannes Vermeer, momentaneamente lontando da Delft per un viaggio d’affari all’Aja; Catharina Bolnes, moglie del pittore, Maria Thins, la di lei madre, e un’immaginaria modella di nome Saskia de Vries raccontano a Veermer i piccoli fatti della vita domestica quotidiana – un progetto di matrimonio fallito e un altro di cui si gettano le basi per la giovane Saskia, la vita dei figli dell’artista – cercando di fargli sentire quanto a loro manchi la sua presenza, pregandolo continuamente di tornare al più presto. Come sempre accade nei lavori in cui è coinvolto Greenaway, la trama procede per allusioni più o meno criptiche a fatti e circostanze che si riescono solo a immaginare in filigrana; per esempio la presenza di cinque fluidi che minacciano la serenità domestica della famiglia: la vernice, che un mattino la piccola Cornelia mangia per gioco, il latte, che continuamente viene versato, il sangue, che simbolizza l’assassinio e la violenza, e infine l’acqua, che negli ultimi secondi dell’opera sommergerà la scena.
Cinque elementi che rappresentano nella loro quotidianità la sotterranea minaccia che il mondo esterno, la storia e l’attualità recano all’apparentemente serena vita della famiglia Vermeer. La storia d’altro canto fa irruzione nell’opera anche attraverso dieci inserti sonori sapientemente incastonati nel dipanarsi del libretto, nei quali essa agisce come in un fondale che lentamente e pericolosamente si avvicina alla scena familiare fino a sommergerla nel finale. Si tratta di dieci momenti della cruenta storia olandese di quei giorni: la dura opposizione tra cattolici e protestanti, un’esplosione a Delft, il crollo del mercato dei tulipani, l’orribile assassinio di due diplomatici olandesi, l’invasione francese, fino all’inondazione con cui gli olandesi si difendono dai francesi, principale causa della rovina di Vermeer secondo i documenti storici. Questi inserti sono realizzati attraverso il live electronic di Michel vad der Aa, che compone cellule melodiche a suoni fortemente relistici: campane da chiesa, esplosioni, respiri affannosi, scrosci d’acqua, urla, passi.
La musica è altrettanto ricca di suggestioni, citazioni rimandi, ma cucita in un tessuto di grande coerenza e fascino; i nomi che vengono in mente o che Andriessen stesso cita nelle note di copertina del disco sono quelli di John Cage per le scelte strutturali e per diverse sonorità, ma anche Steve Reich in alcuni trattamenti delle tastiere, perfino Webern in alcuni momenti di forte rarefazione timbrica e melodica. Il suono combina in maniera davvero brillante la modernità estrema e le sonorità barocche delle esecuzioni filologiche, senza soluzione di continuità e in bellissimo trascolorare da una tavolozza all’altra; la vocalità ricorda talvolta Britten, ma è sempre molto naturale e sciolta. L’orchestra comprende un gruppo di archi inconsuetamente corposo per Andriessen (12 violini, 8 fra viole e violoncelli, due contabbassi), legni, ottoni, due arpe, due chitarre elettriche, due pianoforti e percussioni.
Su tutto domina la sensazione di una profonda comprensione dell’opera pittorica di Vermeer, di quella sospensione del tempo, di quella felicità esclusiva e venata di malinconia e ansia, nella quale l’esterno è sempre alluso (una lettera, una finestra, una porta aperta), ma al tempo stesso tenuto fuori dallo spazio artistico e psicologico; un lavoro in cui realismo e sogno sembrano fondersi in un’unità inscindibile. Un’opera davvero bellissima.
17 Ottobre 2007 § § permalink
 Tempo fa ho letto che lo scrittore libertino Rétif de la Bretonne aveva l’abitudine di incidere sui muri di pietra e gli intonaci dell’Île Saint-Louis, durante le sue passeggiate quotidiane, delle brevi riflessioni o citazioni. Camminando, il ritrovarle lo aiutava a ricordare, e così facendo rese i muri di Parigi un’appendice di sé, in un sontuoso diario personale. “Inscripcions”, le chiamava, con la sua peculiare ortografia. La cosa naturalmente non passava inosservata, e lo scrittore, se sorpreso all’opera, veniva spesso deriso o bersagliato con le pietre. Il tempo recava inoltre i suoi oltraggi, affievolendo la visibilità dei suoi appunti. Fu così che dal 1779 cominciò a trascrivere le sue incisioni su un taccuino, che si trasformò sei anni dopo in un più tradizionale diario quotidiano. D’altro canto, è noto come anche Montaigne riempisse il soffitto del suo studio di frasi e passaggi tratti dalle sue letture.
Tempo fa ho letto che lo scrittore libertino Rétif de la Bretonne aveva l’abitudine di incidere sui muri di pietra e gli intonaci dell’Île Saint-Louis, durante le sue passeggiate quotidiane, delle brevi riflessioni o citazioni. Camminando, il ritrovarle lo aiutava a ricordare, e così facendo rese i muri di Parigi un’appendice di sé, in un sontuoso diario personale. “Inscripcions”, le chiamava, con la sua peculiare ortografia. La cosa naturalmente non passava inosservata, e lo scrittore, se sorpreso all’opera, veniva spesso deriso o bersagliato con le pietre. Il tempo recava inoltre i suoi oltraggi, affievolendo la visibilità dei suoi appunti. Fu così che dal 1779 cominciò a trascrivere le sue incisioni su un taccuino, che si trasformò sei anni dopo in un più tradizionale diario quotidiano. D’altro canto, è noto come anche Montaigne riempisse il soffitto del suo studio di frasi e passaggi tratti dalle sue letture.
Che cosa c’entra tutto questo con Fierrabras? Poco o nulla, forse, ma già mostra una delle modalità con cui vorrei che si sviluppasse: la libertà e rapsodicità delle annotazioni. Non certamente un diario personale, ma un luogo in cui accumulare liberamente riflessioni, annotazioni e segnalazioni sull’attualità e sul mondo delle arti e delle lettere. Con meno autoreferenzialità possibile, e con la voglia di condividere le esperienze migliori. Non recensioni dunque, perché manca l’autorità del critico; osservazioni e segnalazioni piuttosto, perché possa magari capitare che qualcuno si incuriosisca, e provi a condividere l’esperienza. Per il resto, si vedrà. Meno parole programmatiche si scrivono, meglio è. Spesso un progetto si chiarisce realizzandolo.
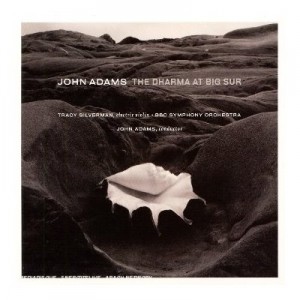 È strano come il concerto solistico, ben lungi dall’essere in qualche modo ridimensionato dalla fine di un mondo, quello del grande concertismo internazionale, continui a generare nei migliori compositori ispirazioni spesso più felici della musica per orchestra. Gli ultimi grandi divi-virtuosi si stanno spegnendo, nascono figure di volta in volta più “glamour” o più tecnicamente preparate, ma difficilmente si potrà ritrovare, almeno nel futuro prossimo, quel particolare carisma che il solista conquistava con l’appartenere a un mondo che aveva qualcosa da dire, che rappresentava qualcosa oltre a se stesso. Eppure di quel mondo si nutriva la forma stessa della musica: difficile pensare al ruolo, alla voce che il violino “porta” nel concerto di Brahms senza Joachim, o al violoncello di Sostakovic senza il rimpianto Rostropovich.
È strano come il concerto solistico, ben lungi dall’essere in qualche modo ridimensionato dalla fine di un mondo, quello del grande concertismo internazionale, continui a generare nei migliori compositori ispirazioni spesso più felici della musica per orchestra. Gli ultimi grandi divi-virtuosi si stanno spegnendo, nascono figure di volta in volta più “glamour” o più tecnicamente preparate, ma difficilmente si potrà ritrovare, almeno nel futuro prossimo, quel particolare carisma che il solista conquistava con l’appartenere a un mondo che aveva qualcosa da dire, che rappresentava qualcosa oltre a se stesso. Eppure di quel mondo si nutriva la forma stessa della musica: difficile pensare al ruolo, alla voce che il violino “porta” nel concerto di Brahms senza Joachim, o al violoncello di Sostakovic senza il rimpianto Rostropovich.