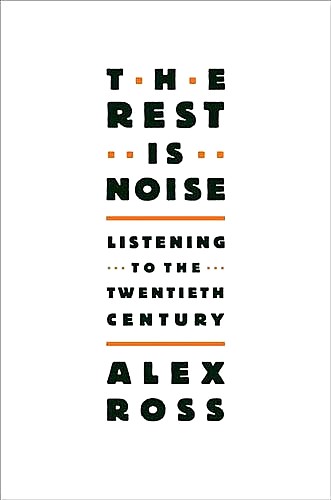22 Settembre 2015 § § permalink
Un po’ di clamore ha fatto nei giorni scorsi nel Regno Unito una caricatura d’epoca di un grande violinista della fine dell’Ottocento, Leopold Auer, pubblicata senza adeguate spiegazioni, sul programma di una serata dei BBC Proms dedicata al Concerto per violino di Čajkovskij:

La vignetta è chiaramente di stampo antisemita, ed è di quelle che fiorirono sui giornali di mezza Europa dalla metà del Diciannovesimo secolo in poi. L’odio razziale che passa attraverso la derisione di un clichè fisico ed “estetico”: Wagner in questo fu un maestro e in un certo senso un capofila, molti altri seguiranno, in un vortice che è molto ben raccontato da un libro di Michael Haas di prossima pubblicazione in Italia (per la EDT). Haas molti lo ricorderanno come il geniale discografico che creò la lunga serie di produzioni Decca intitolata Entartete Musik, “Musica degenerata”, dedicata ai compositori cancellati dalla violenza nazista.
Probabilmente in chi ha curato il programma BBC non c’era la volontà di offendere, c’era solo ignoranza o disattenzione, e l’azienda televisiva inglese si è poi scusata, seppure con qualche ritardo.
Ma qualche mese fa, sui giornali i mezzo mondo, fecero molto discutere i commenti di sapore apertamente antisemita che apparvero persino su giornali importanti alla notizia della nomina di un maestro russo di origine ebraica alla direzione dei Berliner Philharmoniker – e si noti bene che l’altro candidato era il tedeschissimo e nazionalisticamente iperconnotato Christian Thielemann. Anche lì, grandi scuse e cancellazioni e prese di distanza: perdonate, ci siamo sbagliati, non avevamo pensato, non volevamo eccetera. Ma con una mossa abbastanza sorprendente, poco dopo la nomina di Kirill Petrenko a Berlino, i Bayreuter Festspiele, il festival fondato da Richard Wagner e tuttora condotto dai suoi pronipoti, ha nominato Thielemann “direttore musicale”, carica appositamente creata per lui; una mossa che aveva il sapore neanche troppo nascosto di una riparazione e una risposta della “nazione tedesca”.
Il fatto è che questa faccenda della caricatura, in questo periodo, rimanda anche a quella ben più grave di Charlie Hebdo e dei tragici fatti di Parigi e della sollevazione in difesa della libertà di satira e più in generale di pensiero contro l’oscurantismo religioso. Ora, le due vicende sono state messe in relazione persino da quealche colto e sensibile intellettuale (uno per tutti, Bob Shingleton, il curatore di un importante e storico blog musicale).
Ora, a me sembra chiaro che pubblicare una vignetta mediocremente antisemita di un secolo fa, del tutto decontestualizzata, senza spiegazione e senza alcun contenuto di satira politica sia una grave disattenzione da parte di chi si occupa di comunicazione culturale. Che caricatura eè una cosa e vignetta satirica è un’altra (e spesso si confondono le due cose). E che la differenza rispetto a chi utilizza anche violentemente la matita per dileggiare e pungere l’oscurantismo politico/religioso che pervade una parte crescente del pianeta sia abbastanza palese senza bisogno di ulteriori approfondimenti Però devo dire che sono comunque argomenti di una certa delicatezza, e ancora una volta mi trovo a disagio vicino a chi manifesta incrollabili e immediate certezze.
29 Maggio 2013 § § permalink

Di Giacomo Soffiantino ricordo il bellissimo studio sotto la collina torinese, disseminato degli arnesi del mestiere, ricolmo di fossili, bucrani, insetti meravigliosi e oggetti, tracce di una vita che, anche solo all’apparenza, mostrava di esser stata umanamente ricca e vissuta con passione e intelligenza. E naturalmente le tele. Dietro un lenzuolo, dietro il cavalletto. Quelle più violente e scure, di un espressionismo che lasciava intravedere fra grandi fasce di colore le presenze di quelle stesse curiosità da wunderkammer, da stanza delle meraviglie dell’alchimista rinascimentale, di cui si circondava: frammenti di teschi animali, conchiglie, cefalopodi, schegge di legno e sassi. E poi quelle, straordinarie, più chiare e luminose, ma sempre popolate dai segnali di cicli temporali che superano l’orizzonte umano, la gioia e il dolore. E le incisioni, a volte cupe e quasi selvagge, altre grandiosamente intricate.
Eravamo agli inizi di marzo del 2007, mi pare, e ci aveva aperto il cancello con il suo grande camice bianco, fra l’artista e lo scienziato, appunto: appena entrati nel suo studio ho cominciato a chiedermi se stavamo facendo la scelta giusta. Un artista di quell’altezza, dal segno così forte e profondo, avrebbe accettato di chinare gli occhi su degli scorci cittadini? Rotaie, viali, facciate di palazzi celebri visti e rivisti, piazze e monumenti storici, strade trafficate e così legate al tempo e ai ritmi quotidiani. Dario Voltolini ne era sicuro, e girava per lo studio come un bambino in una pasticceria. Con un gesto elegante che si sarebbe ripetuto in ogni incontro successivo, Soffiantino aveva aperto una bottiglia di champagne che la moglie, così gentile e affabile, aveva nel frattempo portato, e dopo qualche sorso e un po’ di chiacchiere tutto aveva cominciato a girare meglio. Era una sfida che gli piaceva: tornare al disegno dal vero, prestarsi al figurativo con un committente, lavorare insieme a uno scrittore su un soggetto al tempo stesso statico e ribollente di vita come una città. La sua città. Nasceva così Torino fatta ad arte, il carnet che univa le visioni di due artisti che avrebbero presto stretto un’amicizia affettuosissima; mi ricordo che Voltolini era rimasto così affascinato dai disegni di Soffiantino che volle prendere da lui lezioni di incisione. Non so se la cosa abbia avuto qualche esito: ho sentito Dario vantarsi diverse volte di una sua opera prima. Mai di una seconda, però.
Soffiantino si fece mandare i testi da Voltolini a mano a mano che li scriveva – e come spesso capita con gli scrittori, a mano a mano vuol dire tutti insieme dopo una nottataccia o due, e poi qualche altro frammento più faticoso, alla spicciolata. Si era preso un po’ di tempo, e un giorno era arrivato in casa editrice con un’enorme cartellina ricolma di fogli. Tutti ricordiamo il grande tavolo della sala riunioni trasformato nella parete di un museo: i fogli uscivano da quella cartellina uno alla volta. Grandi acquerelli alternati a schizzi a matita o a china, frammenti, torsi, particolari architettonici, bozzetti, frecce colorate, paesaggi luminosi. Uno più bello dell’altro, uno più sorprendente di quello vicino. Della sua arte c’era tutto, ma era come se si fosse divertito a nasconderla fra i particolari di un’apparente oggettività. E poi le conversazioni con l’editore, gli incontri col grafico, con la produzione e la redazione, insomma tutte le stazioni che portano alla pubblicazione di un libro. Per la presentazione avevamo scelto una galleria del centro, la Novalis, in una giornata di metà novembre: tutte le tavole originali erano esposte alle pareti, insieme ad alcuni suoi meravigliosi quadri. Al centro un tavolino con una pila di libri freschi di stampa e lui, sorridente, seduto pazientemente a dedicare il libro per una lunga fila di ammiratori. Un’immagine di felicità che diversi anni dopo avrei rivisto a un’altra sua personale, alla Biblioteca Nazionale di Torino: una lunghissima teoria di persone che voleva salutarlo e stringergli la mano, scambiare due parole, chiedere un’informazione su un certo dipinto o su un certo ricordo.
A Soffiantino piaceva il pubblico, l’incontro con le persone capaci di apprezzare il suo lavoro d’artista. Quando questo scambio accadeva, sul suo viso comparivano i segni di una appena trattenuta felicità. E questo può dare un’idea di quanto tutti noi, in casa editrice, siamo stati felici di avere collaborato con lui, e quanto forte sia oggi il rammarico per la sua scomparsa. Perché se poter lavorare con un artista come Giacomo Soffiantino è sempre un privilegio, farlo nel tentativo di creare un’occasione per quell’incontro felice con il suo pubblico – che poi è la parte più bella del lavoro editoriale – è un privilegio doppio, e lascia nella memoria un segno indelebile e, ancora una volta, felice. Ed è con il ricordo di questa immagine sorridente che vorremmo ancora salutarlo, oggi.
* * *
Questo ricordo di Giacomo Soffiantino, scomparso il 27 maggio 2013, è stato originariamente scritto per il sito della EDT.
19 Novembre 2012 § § permalink

Che un grande scrittore come Philip Roth decida di andare in pensione, per così dire, e lo annunci in modo tale da fare del suo proposito il tema letterario più dibattuto del momento, è cosa che dovrebbe fare sorridere. Ma confesso che un particolare della faccenda, così come è stata riportata dalla stampa di tutto il mondo, non riesco a levarmelo dalla mente. Mi perseguita; mi sembra un’immagine troppo forte per non essere stata creata intenzionalmente, e mi domando perché.
Cosa fa al mattino l’autore del Lamento di Portnoy e di Pastorale americana, ora che ha smesso di lottare con le parole? Poteva dire tante cose, ma ne ha detta una che fa un male boia.
Al mattino si sveglia e gioca con l’iPhone.
Se l’è appena comprato, e come tutti, a quanto pare, ci gioca. Come tutto il mondo, come tutti i suoi lettori, come tutti quelli che non lo leggono e forse non lo leggeranno mai. Lui gioca con quella che gli osservatori del secolo hanno definito l’invenzione del secolo, creata dal genio del secolo. Finalmente, dice Roth. Non ne potevo più.
Non so spiegare perché, ma fra tutti gli inutili commenti questo particolare, anzi questa immagine, mi sembra umanamente insopportabile. E forse non ce n’è motivo. Ma il fatto è che la scrittura, come l’amore, mi sembra una lotta che riguarda due forze immaginarie contrapposte, inscindibili, necessarie l’una all’altra. La lotta con la parola è anche la lotta per l’ascolto, e forse ci sono momenti in cui ti accorgi che che non hai niente da dire, perché non c’è niente che possa essere ascoltato fra le cose che potresti avere da dire.
O almeno, non c’è niente che possa essere ascoltato dalle persone di cui le tue parole hanno bisogno per poter essere dette. E allora fai come loro, lasci perdere. Finito.
Ma chi è che ci perde veramente, in questo gioco?
22 Marzo 2011 § § permalink

L’art doit discuter,
doit contester,
doit protester.
L’arte deve discutere, deve contestare, deve protestare. È una visione estetica, e non necessariamente la migliore. Ma la cosa che colpisce è che a pronunciare questa frase sia stato un uomo politico, e non certo un politico di sinistra: Georges Pompidou, Primo ministro a metà degli Sessanta e poi Presidente della Repubblica francese. E non fu solo una frase detta così per dire, ma l’attestazione di una politica culturale e di un investimento. Leggerla sulla facciata del ‘Beaubourg’, il complesso dedicato alla diffusione delle arti che porta il suo nome, colpisce oggi più che mai, e non tanto (o non solo) per via della totale mancanza di una visione estetica da parte dell’attuale classe politica, ma anche per una questione di linguaggio. Si pensi anche solo ai modi superficialmente sussiegosi e segretamente sprezzanti con cui l’arte è oggi trattata nei discorsi politici. Anzi, non è trattata, perché quasi mai si parla di arte, ma sempre di ‘cultura’. La cultura è quella cosa a cui bisogna dare i soldi, perché quel paese ne dà più di noi, e quell’altro ancora di più, e così via, in un umiliante ritornello. Sembra che nelle orecchie dei cittadini italiani la parola cultura non possa più essere divisa dalla parola soldi. È il frutto di una efferata, silenziosa vendetta del mondo politico: rendere l’artista un questuante, una sorta di arcaico sottoproletario da difendere dalla fame o da abbandonare a se stesso, a seconda della parte a cui si appartiene. Ma tutti sanno ciò che non vogliono dire: è la politica, questa politica, che è arcaica, non l’arte. Perché l’arte discute, contesta e protesta. La politica non più.
3 Marzo 2010 § § permalink
Tre giornate per ricordare Sergio Sablich, una delle voci più appassionate ed autorevoli della cultura italiana degli ultimi decenni, musicologo, critico musicale e docente, che all’attività di studioso ha alternato quella di organizzatore musicale come direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale e dell’Orchestra della Toscana, sovrintendente dell’Opera di Roma e consulente artistico del Teatro alla Scala. Un progetto del Museo Nazionale del Cinema, del DAMS di Torino e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
A cinque anni dalla prematura scomparsa di Sergio Sablich, musicologo e importante collezionista bergmaniano, avvenuta il 7 marzo 2005 all’età di 54 anni in seguito ad un ictus cerebrale, Torino rende omaggio a questo intellettuale colto, curioso e raffinato dal 3 al 5 marzo con un articolato omaggio che comprende un convegno del DAMS sul grande regista svedese Ingmar Bergman, un concerto dell’Orchestra Sinfonica della Rai e una proiezione al Cinema Massimo.
Comincia così il comunicato stampa che annuncia le tre giornate di studio (e un po’ anche di festa culturale) che Torino dedica a Sergio Sablich. Per il programma completo rimando al sito che la famiglia e gli amici gli hanno dedicato e che raccoglie una quantità straordinaria di cose interessanti da leggere.
E così sono passati quasi cinque anni da quando Sergio Sablich ci ha lasciati. E quanti ne sono passati da quando ha lasciato Torino? Circa dodici. Da quel 1998 in cui decise di lasciare la direzione artistica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, e di affrontare l’azzardo della sovrintendenza dell’Opera di Roma.
Dodici anni. Volati? Direi di no. Passati piuttosto con il peso di un trattore sulla cultura italiana. Credo che in molti, e non solo a Torino, si ricorderanno delle sue stagioni Rai: senza abbandonarsi troppo alla retorica, si potrebbe dire che erano attraversate da uno slancio emotivo e intellettuale probabilmente irripetibile.
Quando decise di accettare Roma, gran parte degli amici torinesi storsero la bocca. Perché lasciare la solidità di una casa costruita con fatica, mattone su mattone, per ricominciare tutto in un posto franoso e fangoso, dove notoriamente gli amici sono della ventura e i nemici perfidi e insidiosi? I torinesi inoltre (lo so per appartenenza alla categoria), erano convinti che la loro città, la loro bella orchestra, le tante occasioni che quel lavoro offriva non potessero che corrispondere perfettamente alla sua indole, saziare ogni sua brama. Com’era arrischiata per loro quella partenza: foriera di infelicità.
E Roma andò male; poi anche la Scala non andò bene: Milano si mostrò infida quanto Roma. Ma in realtà era l’Italia della cultura a essere diventata sempre più infida: era un mondo in cui stava finendo un’epoca di certezze politiche, e che stava ridisegnando la propria geografia. Sablich era una vera eccezione culturale: non capivi mai bene con chi stesse, se giudicavi con una divisa addosso. Avrebbe dovuto essere la persona più adatta ad avvantaggiarsi di quel momento: probabilmente proprio per questo fu sentito come una minaccia.
Ma allora avevano ragione i torinesi? Per dirla con Peter Grimes, “Then the Borough’s right again?”: il Borgo ha di nuovo ragione? Ora che Torino ricorda Sablich, e sono passati cinque e poi dodici anni, mi piacerebbe che Torino riflettesse su cosa può ancora imparare dalla storia di Sablich. Certo, c’è il convegno dedicato a Bergman, il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la proiezione cinematografica. Ma non basta.
Il fatto è che costruire qualcosa, e non solo nel mondo della cultura e delle arti, richiede, ma vorrei dire pretende, un solido amore per l’avventura intellettuale. Il cambiamento, anche arrischiato, la ricerca, il disagio per ciò che si è assestato su una routine, anche fosse una routine virtuosa. E qui non alludo a quella finta curiosità che fa mettere insieme un pezzetto di disordine nel sacro equilibrio: il programmino postmoderno, la ricercuzza pop, il trombonista jazz nel concerto mozartiano. Questi sono i cacciatori da Safari: un’organizzazione poderosa e costosissima li porta in mezzo a una finta jungla, loro sparano un colpo e tornano a casa col trofeo per il salotto.
Quella di cui parlo è la vera inquietudine intellettuale. Quella che costringe a esplorare se non terre nuove, profondità nuove. Quella che esaspera gli amici, i collaboratori, le persone care; che ti porta a fare un pezzo del viaggio in compagnia di gente poco raccomandabile, e magari a commettere degli errori; quella, però, senza la quale non ci può essere alcuna vera crescita umana e intellettuale. Rispettare questa irrequietezza, coltivarne i frutti, imparare da essa a non pensare che ciò che si ha sia abbastanza per tutti: è su questo, oltre che sulle tante belle pagine di vita e di spettacolo, che mi piacerebbe che Torino – tutte le Torino del mondo – riflettessero ricordando Sergio Sablich.
8 Ottobre 2009 § § permalink

Da secoli si discetta e filosofeggia sulla musica come linguaggio. Mi sono per caso imbattuto in un filmato piuttosto sorprendente, e volevo condividerlo. Un compositore austriaco, Peter Ablinger, ha fatto recitare a un bambino berlinese la Proclamazione (in inglese) della Corte penale internazionale dell’ambiente, poi ne ha analizzato il suono e lo ha ricomposto in un complessissimo ‘spartito’ per pianoforte azionato meccanicamente attraverso un sistema computerizzato. Il risultato è un pianoforte che parla. Letteralmente!
Ablinger, nato nel 1959, non è nuovo a questo tipo di performance, e un’occhiata al suo catalogo può far capire la varietà delle sue trovate. La foto qui sopra ritrae un’esecuzione berlinese di “A Letter from Schoenberg, reading piece for ministers for player piano and an audience reading the text while hearing the piece”, tratto dalla raccolta Quadraturen III (lo si può ascoltare qui) In quel caso, il pianoforte ‘suonava’ una lettera di Schoenberg.
La nuova composizione è stata presentata alcuni giorni fa al World Venice Forum 2009 (Venezia, 2–3 ottobre), dedicato per l’appunto alla creazione di una Corte mondiale e di una Corte europea per i crimini ambientali. Il filmato è un frammento di un documentario tedesco dedicato all’opera.
Personalmente non lo ritengo molto più interessante di una curiosità da fiera – d’altronde più di una volta la musica ‘d’avanguardia’ mi ha dato questa sensazione. E al tempo stesso, tuttavia, devo ammettere che accanto all’ammirazione per il marchingegno, la performance mi ha dato da pensare. È musica? È teatro? Qualcosa che sta in mezzo? Spesso sono le cose spiazzanti e apparentemente anodine quelle che aiutano a riflettere meglio.
5 Ottobre 2009 § § permalink

Quanti anni sono passati da quando il mercato discografico è entrato nella sua crisi senza fine? Da quanto tempo si assiste all’invecchiamento del pubblico dei concerti classici, al prosciugarsi della spinta estetica e innovativa dello spettacolo dal vivo? Quante spiegazioni sono state cercate, quante vie d’uscita sono state indagate? Nel frattempo, sulla già fragile economia della musica si sono abbattuti il crollo del sistema finanziario, la recessione, i tagli, la disoccupazione. Si è molto parlato della fine di un sistema, così come pareva giunto al capolinea un costume finanziario che aveva portato l’economia mondiale al collasso. E invece, ai primi segni di ripresa, ecco che a Wall Street si vedono rispuntare i superbonus per i manager, i derivati, i titoli spazzatura e via dicendo. E nel mondo della musica? Tanti studi, tanti convegni, tante parole. E nel frattempo, un po’ come a Wall Street, cosa stavano facendo gli intelligentissimi supermanager del big business musicale?
È molto semplice. Stavano cercando un nuovo Bernstein. Quello hanno imparato a fare, quello ancora sanno fare, e quello faranno, perché nel frattempo non hanno maturato nient’altro. In fondo è un po’ come vendere titoli spazzatura: li si occulta in un pacchetto complessivamente attraente sperando che nessuno abbia voglia di guardare troppo a fondo, e li si spaccia per meraviglie. A un certo punto però il sistema cede, e tutti si chiedono il perché. Abbiamo distrutto un mercato drogandolo di tre tenori, di incredibili porcherie crossover per un pubblico umiliato da grande fratello? Abbiamo scavato ogni recesso della volgarità e del kitsch, utilizzato ogni possibile appiglio per rendere appetibile un genere musicale a chi non lo vuole, tirando calci a chi finora ci aveva mantenuto? E ora che, dopo il prevedibile tracollo, qualcosa sembra tornare a muoversi che cosa facciamo? Ricominciamo da capo, naturalmente.
È quello che potrebbe venire in mente a chi osservasse l’incredibile onda mediatica che si diffonde dalla California, in questi giorni, per l’incoronazione di Dudamel a direttore della Los Angeles Philharmonic. Senza un nuovo eroe su cui investire tutti gli spiccioli rimasti, sembra sia impossibile progettare una qualsiasi ripresa. Ed ecco che il passaggio di un giovane (e bravo, per carità) direttore alla guida di una delle grandi orchestre americane non può che diventare un lancio in stile Hollywood, con tanto di brand (Gustavo!), minisiti, tecniche aggressive di marketing e persino un giochino elettronico, finanziato dall’orchestra, che ha fatto il giro del mondo.
È la strada giusta per uscire dalla crisi? Inutile domandarselo: è l’unica che questa industria dello spettacolo, i suoi finanziatori e i suoi improbabili manager, sappiano trovare. Personalmente la definirei una coazione a ripetere che ha del patologico. Ma immagino che trovare qualsiasi altra strada avrebbe comportato così tanto lavoro e così tante sfide intellettuali ed economiche che la sola speranza sarebbe stata da folli. Senza contare, e questo è forse l’elemento determinante, che sarebbe stato tutto infinitamente meno divertente. Il grande business della musica è un vecchio malato che gioca a fare il bambino, diviso tra la flebo e la playstation. Quello che ci chiede è solo di chiudere gli occhi e di giocare con lui; tutto tornerà come prima, promesso.
3 Ottobre 2009 § § permalink
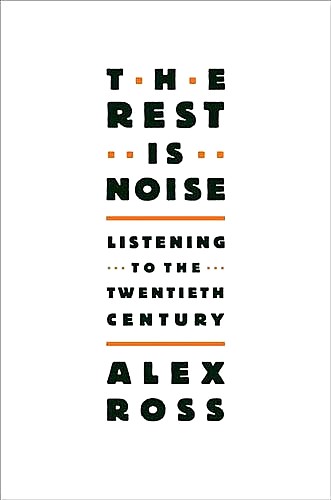
Riemergendo faticosamente da un periodo di lavoro molto intenso (è un modo per giustificare il lungo silenzio di Fierrabras), trovo questo articolo di Pierre Assouline nel suo blog “La République des Livres” (sul sito di “Le Monde”), e lo segnalo per una curiosa coincidenza.
Finalmente un grande libro
Come mi capitò di scrivere in un post della fine del 2007, una delle letture musicali più appassionanti del 2008 (probabilmente il miglior testo sulla musica da molti anni a questa parte) è stato il libro dedicato al Novecento musicale da Alex Ross, il bravissimo critico del “New Yorker” il cui blog da sempre figura nella lista dei siti preferiti di Fierrabras (anche se da quando è uscito il libro si è come prosciugato: destino di tanti bellissimi blog negli ultimi tempi: prima o poi converrà parlarne).
The Rest is Noise, il libro di Ross, è una splendida sintesi delle tante e diverse linee di sviluppo del Novecento musicale; Ross è un profondo conoscitore della musica americana, eppure curiosamente si tratta di un libro profondamente europeo. Europeo perché è basato sui valori, le curiosità, il modo di ragionare e di guardare al bello e al brutto che costituisce la forza (e forse per certi aspetti anche il limite) della cultura europea. Dicono che New York sia la città più europea degli Stati Uniti, e allora bisognerebbe dire che è un libro profondamente newyorkese.
Se mi chiedessero che cosa contiene di rivoluzionario The Rest is Noise, non saprei rispondere su due piedi alla domanda. Basta sfogliarlo per capire che non si tratta di un libro che vuole cambiare le idee di alcuno: non c’è, per dire, lo spirito battagliero della History of Western Music di Taruskin (per citare un’altra opera importante degli ultimi anni). Gli equilibri, gli spazi, le parole su ogni aspetto del mondo musicale sono gli stessi che presumibilmente gli destinerebbe un buon professore di un nostro conservatorio. Strauss, Mahler, Schoenberg, Stravinsky, e via via come di consueto (come è giusto direi), il jazz, fino al minimalismo e al postminimalismo. Ognuno poi ha le sue piccole fissazioni: chi ha seguito il suo blog sa che Ross adora Sibelius, e naturalmente le venti pagine del capitolo “Apparition from the Wood” (sottotitolo quasi compassionevole “The Loneliness of Jean Sibelius”) sono un concentrato di amore e competenza; d’altro canto, per chi scrive, le quattro striminzite pagine dedicate a Bernstein sembrano piuttosto pochine; tra l’altro ben scritte, ma non certo esaurienti. Ma si sa: ognuno ha le sue passioni.
Forse dovendo spiegare perché quello di Ross è un grande libro metterei al primo posto tre elementi: il linguaggio, il taglio con cui la materia è presentata, lo spirito didattico. Ross scrive con una fermezza e un equilibrio nel giudicare, con una competenza tecnica e un rispetto per le diverse correnti estetiche che non è merce comunissima tra le storie della musica non scolastiche. Ma accanto all’aspetto tecnico, ciò che colpisce è la sua voglia di descrivere i personaggi, le atmosfere, gli incontri straordinari che chiunque decidesse di percorre le strade del Novecento musicale farebbe. Un gusto che non rifiuta l’aneddotica senza renderla bozzetto o peggio ancora pettegolezzo. » Read the rest of this entry «
8 Settembre 2009 § § permalink
Con gialle pere scende
E folta di rose selvatiche
La terra nel lago,
Amati cigni,
E voi ubriachi di baci
Tuffate il capo
Nell’acqua sobria e sacra.
Ahimè, dove trovare, quando
È inverno, i fiori, e dove
Il raggio del sole,
E l’ombra della terra?
I muri stanno
Afoni e freddi, nel vento
Stridono le bandiere.
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Si può anche solo immaginare poesia più bella e profonda di Hälfte des Lebens, “Metà della vita”, di Friedrich Hölderlin? Credo di non esagerare se dico che si tratta di una delle più belle della letteratura europea. Quella prima strofa così sensuale, con una divisione che è un inno alla completezza: la superficie dell’acqua che separa il visibile dall’invisibile, e tutto che sembra volere trapassare, felicemente, da una parta all’altra; la terra con i suoi frutti dell’esperienza – le pere mature – e i suoi fiori selvatici – le rose –, i cigni che nuotando immergendo il collo, “ebbri di baci”, in un sacro, sensuale abbraccio. E l’altra metà, quella dell’inverno, fatta di elementi infertili e impenetrabili – i muri freddi e muti – di segnali privi di desiderio e volontà – le banderuole al vento. Com’è lontana la fiducia nel ciclico tornare delle stagioni che tanta parte della cultura occidentale aveva nutrito, dalla natura di Lucrezio ai meravigliosi mesi di Benedetto Antelami nel battistero del Duomo di Parma – e sul portale del Duomo di Fidenza e su quello di Cremona, e di chissà quante altre architetture romaniche – dai concerti delle Stagioni di Vivaldi a quelle di Haydn. Quello che viene piuttosto da chiedersi e se Wilhelm Müller, l’autore delle poesie che poi Schubert, con folgorante intuizione ha raccolto nella Winterreise, “Viaggio d’inverno”, conoscesse questa poesia. La raccolta di Müller era stata pubblicata sulla rivista “Urania” nel 1823. L’immagine della banderuola segnavento, ‘die Wetterfähne’, così lacerantemente trasfigurata da Schubert, sembrerebbe quasi una citazione letterale. Si potrebbe persino dire che in questi 14 versi sia prefigurato in breve l’intero ciclo schubertiano. » Read the rest of this entry «
15 Luglio 2009 § § permalink
Mentre alcuni nuovi pezzi di Fierrebras non vogliono proprio scriversi da soli, ci sono mille notizie dal mondo della musica che mi piacerebbe condividere. Notizie che riflettono quanto esso sia complesso, articolato e un poco pazzo. Eccone tre di ieri.
La prima è una bella inchiesta del New Music Box, il sito internet dell’American Music Center, dedicata alla buona salute di cui godono – in un mercato discografico sconvolto dalla crisi economica e di idee – le etichette indipendenti specializzate nella produzione e distribuzione di musica contemporanea. Il loro modello di business non è certo quello delle major (i compositori o gli sponsor normalmente pagano la produzione del disco) ma il loro insostituibile compito è ricambiato da un successo che sta assumendo le dimensioni di un boom. Contro qualsiasi fosca previsione.
La seconda e la terza sono collegate. Un articolo del Times ci racconta del primo sciopero proclamato dai lavoratori del Festival di Bayreuth. Si tratta di 60 macchinisti e di un centinaio di lavoratori a contratto che contestano la legalità dei contratti firmati dall’ex direttore del Festival, Wolfgang Wagner. E così, mentre si lavora per mandare in scena l’ennesimo, sontuoso Tristan und Isolde, davanti alla consueta platea luccicante di uomini politici, magnati della finanza e alta borghesia internazionale, scopriamo che la paga oraria di un macchinista, di un elettricista o di un attrezzista impegnati sul palcoscenico è di circa 4 euro. Contemporaneamente, un articolo pubblicato sul sito di Bloomberg ci informa del fatto che Peter Gelb ha guadagnato nel 2008 circa 1,5 milioni di dollari con il suo lavoro di General Manager alla Metropolitan Opera di New York, con un incremento rispetto all’anno precedente del 36%. Che cosa c’entra? Boh, ognuno si faccia il suo parere.